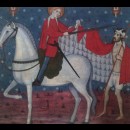| Memoriae proditum est, quo die urbem divus Augustus Apollonia reversus intravit, circa solem visum coloris varii circulum, qualis esse in arcu solet Hunc Graeci halo vocant, nos dicere coronam aptissime possumus Quae quemadmodum fieri dicatur, exponam [2] Cum in piscinam lapis missus est, videmus in multos orbes aquam discedere et fieri primum angustissimum orbem, deinde laxiorem ac deinde alios maiores, donec evanescat impetus et in planitiem immotarum aquarum solvatur; tale quiddam cogitemus fieri etiam in aere: cum spissior factus est, sentire plagam potest; lux solis aut lunae vel cuiuslibet sideris incurrens recedere illum in circulos cogito |
stato tramandato che nel giorno in cui il divo Augusto, di ritorno da Apollonia, entrò a Roma, attorno al sole fu visto un cerchio di vario colore, come di solito si trova nellarcobaleno I Greci chiamano questo fenomeno hàlos, noi possiamo benissimo chiamarlo corona Esporrò in che modo si dice che esso si verifichi [2] Quando si getta una pietra in una piscina, vediamo che lacqua si allarga in molti cerchi e che dapprima si forma un cerchio molto piccolo, poi più largo e poi altri sempre più ampi, finché limpulso non si esaurisce e si esaurisce nella quiete della superficie immobile dellacqua; qualcosa di simile pensiamo che accada anche nellaria: quando è diventata abbastanza densa, può sentire i colpi che riceve; la luce del sole o della luna o di qualsiasi astro che la colpisce la costringe a ritirarsi formando dei cerchi |
| Nam umor et aer et omne, quod ex ictu formam accipit, in talem habitum impellitur, qualis est eius, quod impellit; omne autem lumen rotundum est: ergo et aer in hunc modum lumine percussus exibit [3] Ob hoc tales splendores Graeci areas vocaverunt, quia fere terendis frugibus destinata loca rotunda sunt Non est autem, quod existimemus istas, sive areae sive coronae sunt, in vicinia siderum fieri Plurimum enim ab his abstint, quamvis cingere ea et coronare videantur: non longe a terra fit talis effigies, quam visus noster solita imbecillitate deceptus circa ipsum sidus putat positam [4] In vicinia autem stellarum et solis nihil tale fieri potest, quia illic tenuis aether est |
Infatti, un liquido, laria e ogni sostanza che prende forma dal colpo che riceve, sono spinti ad assumere la forma di ciò che li colpisce; ma ogni oggetto luminoso è rotondo: dunque, anche laria, colpita dalla luce, assumerà questo aspetto [3] I Greci hanno chiamato questi aloni aie, proprio perché le aree destinate alla trebbiatura del grano sono quasi sempre rotonde Non cè motivo per ritenere che questi fenomeni, siano essi aie o corone, avvengano nelle vicinanze degli astri Sono, infatti, molto lontano da essi, benché sembrino circondarli a forma di corona: si forma non lontano da terra quellimmagine che la nostra vista, ingannata dalla solita debolezza, crede si trovi intorno allastro stesso [4] Ma nelle vicinanze delle stelle e del sole non può avvenire niente di simile, poiché lì letere è sottile |
| Nam formae crassis demum spissisque corporibus imprimi solent, in subtilibus non habent, ubi consistant aut haereant: in balneis quoque circa lucernam tale quiddam aspici solet ob aeris densi obscuritatem, frequentissime autem austro, cum caelum maxime grave et spissum est [5] Nonnumquam paulatim diluuntur et desinunt, nonnumquam ab aliqua parte rumpuntur et inde ventum nautici expectant, unde contextus coronae periit: si a septemtrione discessit, aquilo erit, si ab occidente, favonius Quod argumentum est intra eam partem caeli has fieri coronas, intra quam venti quoque esse solent: superiora non habent coronas, quia ne ventos quidem [6] His argumentis et illud adice, numquam coronam colligi nisi stabili aere et pigro vento; aliter non solet aspici |
Infatti, le forme sono impresse di solito soltanto su corpi grossi e spessi, mentre su quelli sottili non hanno dove fermarsi e di aderire: anche nei bagni si è soliti vedere qualcosa del genere intorno alla lucerna, a causa delloscurità dellaria densa, e molto spesso con lAustro, quando latmosfera è particolarmente pesante e spessa [5] Talvolta gli aloni si dissipano a poco a poco e svaniscono, talvolta si squarciano da una parte, e i marinai aspettano che il vento si levi di là donde lintreccio della corona è venuto meno: se a nord sarà aquilone, se a ovest sarà zefiro Questa è la prova che queste corone si formano entro quella parte di cielo nella quale di solito soffiano anche i venti: le regioni superiori non hanno corone, poiché non ci sono neppure venti [6] A queste prove aggiungi anche questa, che una corona non si raccoglie mai, se non con laria tranquilla e il vento debole; in altre condizioni non è visibile |
Maybe you might be interested
Seneca, Naturales Quaestiones: Libro 03; 21-25
Latino: dall'autore Seneca, opera Naturales Quaestiones parte Libro 03; 21-25
| Nam qui stat aer, impelli et diduci et in aliquam faciem fingi potest; is autem qui fluit ne feritur quidem lumine (non enim resistit nec formatur, quia prima quaeque pars eius dissipatur): [7] numquam ergo ullum sidus talem sibi efligiem circumdabit, nisi cum aer erit densus atque immotus et ob hoc custodiens incidentem in se rotundi lineam luminis Nec sine causa; repete enim exemplum, quod paulo ante proposui: lapillus in piscinam aut lacum et alligatam aquam missus circulos facit innumerabiles; at hoc idem non faciet in flumine (quare Quia omnem figuram fugiens aqua disturbat): idem ergo in aere evenit, ut ille, qui manet, possit figurari, at ille, qui rapitur et currit, non det sui potestatem et omnem ictum venientemque formam ex eo turbet |
Infatti, laria che resta ferma può essere spinta, separata e plasmata in qualche forma; quella che, invece, è in movimento non può essere neppure colpita dalla luce (infatti, non oppone resistenza e non assume una forma determinata, poiché si dissolve a poco a poco): [7] dunque, nessun astro si circonderà mai di tale immagine, se non quando laria sarà densa e immobile e perciò capace di conservare i contorni di un corpo luminoso rotondo che la colpisce con i suoi raggi E non senza ragione: ritorna allesempio che ho addotto poco prima: una pietruzza gettata in una piscina o in un lago o in acque immobili produce innumerevoli cerchi; ma non fa lo stesso in un fiume (perché Perché lacqua scorrendo scompiglia ogni figura): la stessa cosa avviene, dunque, nellaria che, quando resta ferma, può ricevere figure, mentre quando si muove velocemente e corre, non può essere controllata e respinge qualsiasi colpo, rovinando la forma che ne potrebbe conseguire |
| [8] Hae, de quibus dixi, coronae cum dilapsae sunt aequaliter et in semet ipsae evanverunt, significatur quies aeris et otium et tranquillitas; cum ad unam partem cesserunt, illinc ventus est, unde finduntur; si ruptae pluribus locis surt, tempestas fit [9] Quare id accidat, ex his, quae iam exposui, intellegi potest Nam si facies universa subsedit, apparet temperatum esse aera, et sic placidum; si ab una parte intercisa est, apparet inde aera incumbere: et ideo illa regio ventum dabit At cum undique lacerata et concerpta est, manifestum est a pluribus partibus in illam impetum fieri et inquietum aera hinc atque illinc assilire: itaque ex hac inconstantia caeli tam multa temptantis et undique laborantis apparet futura tempestas ventorum plurium |
[8] Queste corone di cui ho parlato, quando si sono dissolte uniformemente e sono svanite riassorbendosi in se stesse, indicano che latmosfera è quieta, immobile e tranquilla; quando, invece, si sono ritirate da una parte, cè vento che soffia da quella parte dove si è creata lapertura; se si sono squarciate in più punti, cè tempesta [9] Perché ciò avvenga, si può capire dalle spiegazioni che ho già dato Infatti, se la forma luminosa scompare del tutto, è evidente che latmosfera è in equilibrio e che il tempo è bello; se si è spezzato da una parte sola, è evidente che laria irromperà da lì: e perciò il vento verrà da quella regione Ma quando si è lacerato e strappato dappertutto, è chiaro che è stato colpito da più parti e che laria lo ha assalito di qua e di là; perciò è chiaro che da questa agitazione di unatmosfera che moltiplica i suoi assalti e che si sforza da tutte le parti deriverà una tempesta con molti venti |
Maybe you might be interested
Seneca, Naturales Quaestiones: Libro 06; 21-25
Latino: dall'autore Seneca, opera Naturales Quaestiones parte Libro 06; 21-25
| [10] Hae coronae noctibus fere circa lunam et alias stellas notantur, interdiu raro, adeo ut quidam ex Graecis negaverint omnino eas fieri, cum illos historiae coarguant Causa autem raritatis haec est, quod solis fortius lumen est et aer ipse agitatus ab illo calefactusque solutior: lunae inertior vis est ideoque facilius a circumposito aere sustinetur; [11] aeque cetera sidera infirma sunt nec perrumpere aera vi sua possunt: excipitur itaque illorum imago et in materia solidiore ac minus cedente servatur Debet enim aer nec tam spissus esse, ut excludat ac summoveat a se lumen immissum, nec tam tenuis aut solutus, ut nullam venientibus radiis moram praebeat |
[10] Queste corone si osservano per lo più di notte attorno alla luna e alle altre stelle, di giorno raramente, tanto che alcuni Greci hanno negato del tutto che esse possano formarsi, benché i racconti storici li confutino La causa di questa rarità è che la luce del sole è più forte e laria stessa, agitata e resa più calda da esso, diventa più leggera: quella della luna, invece, ha minor vigore, e perciò gli aloni sono mantenuti dallaria che la circonda; [11] gli altri astri emanano una luce ugualmente debole che con la propria forza non è in grado di aprirsi un passaggio attraverso latmosfera: la loro immagine viene accolta e conservata in una materia più solida e meno cedevole Laria, infatti non deve essere né così spessa da non lasciar passare e da respingere la luce, né così sottile e rarefatta da non offrire alcun ostacolo al passaggio dei raggi |
| Haec noctibus temperatura contingit, cum sidera circumiectum aera luce leni non pugnaciter nec aspere feriunt spissioremque, quam solet esse interdiu, inficiunt | Questo equilibrio si verifica di notte, quando gli astri colpiscono con una luce tenue senza violenza e senza durezza laria che li circonda, e la colorano perché è più densa di quanto suol essere durante il giorno |