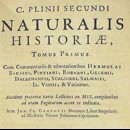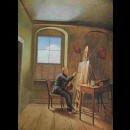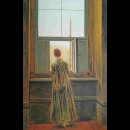| [262] contra mulierum paucis prodigiosa adsimulatio, sicut hermaphroditis utriusque sexus, quod etiam quadripedum generi accidisse Neronis principatu primum arbitror ostentabat certe hermaphroditas subiunctas carpento suo equas, in Treverico Galliae agro repertas: ceu plane visenda res esset principem terrarum insidere portentis [263] Testes pecori armentoque ad crura decidui, subus adnexi delphino praelongi ultima conduntur alvo; et elephanto occulti ova parientium lumbis intus adhaerent, qualia ocissima in venere piscibus serpentibusque nulli, sed eorum vice binae ad genitalia a renibus venae buteonibus terni homini tantum iniuria aut sponte naturae franguntur, idque tertium ab hermaphroditis et spadonibus semiviri genus habent Mares in omni genere fortiores sunt praeterquam pantheris et ursis |
[262] Al contrario per poche donne una strana somiglianza, come per gli ermafroditi di entrambi i sessi, questo credo essere accaduto anche al genere dei quadrupedi dapprima durante il principato di Nerone Certamente mostrava cavalle ermafrodite aggiogate al suo carro, trovate nel territorio di Treviri della Gallia: come fosse veramente una cosa da ammirare che un principe di terre sedesse su mostri che lo trasportano [263] Alla pecora e al montone i testicoli appesi vicino alle zampe, ai maiali aderenti Al delfino molto lunghi sono nascosti nel basso ventre; nascosti anche all'elefante Aderiscono internamente ai reni di quelli che depongono uova, come di quelli velocissimi nell'accoppiamento Niente per i pesci ed i serpenti, ma al loro posto due vene dai reni ai genitali Tre per i bozzaghi Solo per l'uomo sono distrutti da un colpo o per volontà della natura, perciò hanno un terzo genere di mezzi uomini dopo gli ermafroditi e gli eunuchi In ogni specie i maschi sono più forti eccetto per le pantere e gli orsi |
| [264] Caudae praeter hominem ac simias omnibus fere et animal et ova gignentibus, pro desiderio corporum nudae hirtis, ut apris, parvae villosis, ut ursis, praelongae saetosis, ut equis amputatae lacertis et serpentibus renascuntur piscium meatus gubernaculi modo regunt atque etiam in dexteram ac laevam motae ut remigio quodam inpellunt Lacertis inveniuntur et geminae [265] boum caudis longissimus caulis atque in ima parte hirtus; idem asinis longior quam equis, sed saetosus veterinis leoni in prima parte ut bubus et sorici, pantheris non item; vulpibus et lupis villosus ut ovibus, quibus procerior sues intorquent, canum degeneres sub alvum reflectunt [266] Vocem non habere nisi quae pulmonem et arterias habeant, hoc est nisi quae spirent, Aristoteles putat |
[264] Le code quasi per tutti quelli che generano un essere e le uova, tranne l'uomo e le scimmie, secondo l'esigenza dei corpi, spoglie per gli irsuti, come per i cinghiali, piccole per i pelosi, come per gli orsi, molto lunghe per quelli con setole, come per i cavalli Tagliate, ricrescono alle lucertole e ai serpenti Al modo di un timone dirigono i corsi dei pesci e mosse a destra e sinistra spingono quasi come un remo Vengono trovate lucertole anche con due (code) [265] Lunghissimo il fusto della coda dei buoi e irto nella parte bassa; lo stesso più lungo per gli asini che per i cavalli, ma setoloso per le bestie da soma Al leone nella prima parte come per i buoi e i topi, non ugualmente per le pantere; per le volpi ed i lupi villoso come per le pecore, a cui (è) più lungo I maiali l'attorcigliano, i cani bastardi la piegano sotto il ventre [266] Aristotele ritiene che la voce non l'abbiano se non quelli che hanno polmone ed arterie, cioè se non quelli che respirano |
| idcirco et insectis sonum esse, non vocem, intus inmeante spiritu et incluso sonante; alia murmur edere, ut apes, alia contractum stridorem, ut cicadas, receptum enim duobus sub pectore cavis spiritum, mobili occursante membrana intus, attritu eius sonare muscas, apes, cetera similia cum volatu et incipere audiri et desinere, sonum enim attritu et interiore aura, non anima, reddi; locustas pinnarum et feminum attritu sonare [267] credatur sane item aquatilium pectines stridere, cum volant, mollia et crusta intecta nec vocem nec sonum ullum habere: sed ceteri pisces, quamvis pulmone et arteria careant, non in totum sine ullo sunt sono stridorem eum dentibus fieri cavillantur, et is, qui caper vocatur in Acheloo amne, grunnitum habet et alii, de quibus diximus ova parientibus sibilius, serpentibus longus, testudini abruptus |
Pertanto che anche per gli insetti ci sia un suono, non la voce, con l'aria che penetra all'interno e che risuona chiusa; che altri emettano un ronzio, come le api, altri un rumore limitato, come le cicale, infatti l'aria entrata in due cavità sotto il petto, opponendosi dentro una membrana mobile, risuona per il suo attrito Che le mosche, le api, gli altri simili cominciano a sentirsi e a smettere col volo, che infatti il suono è prodotto dall'attrito e dall'aria interna, non dal respiro; che le locuste risuonano per l'attrito delle ali e delle cosce [267] Si creda pure che degli acquatici anche i pettini stridono, quando volano, che molluschi e crostacei scoperti non abbiano alcuna voce né suono: ma gli altri pesci, sebbene siano privi del polmone e della trachea, non sono del tutto senza quel suono-sottilizzano che quel rumore avviene con i denti-, e quello che, nel fiume Acheloo è chiamato capro, ha un grugnito e altri, di cui abbiamo parlato Un sibilo per quelli che depongono le uova, lungi per i serpenti, interrotto per la tartaruga |
Maybe you might be interested
Plinio il Vecchio, Naturalis Historia: Libro 13, Paragrafi 93-142
Latino: dall'autore Plinio il Vecchio, opera Naturalis Historia parte Libro 13, Paragrafi 93-142
| ranis sui generis, ut dictum est, nisi si et in his ferenda dubitatio est, quia vox in ore concipitur, non in pectore multum tamen in his refert et locorum natura: mutae in Macedonia traduntur, muti et apri [268] avium loquaciores quae minores, et circa coitus maxime: aliis in pugna vox, ut coturnicibus, aliis ante pugnam, ut perdicibus, aliis cum vicere, ut gallinaceis iisdem sua maribus, aliis eadem et feminis, ut lusciniarum generi quaedam toto anno canunt, quaedam certis temporibus, ut in singulis dictum est [269] elephans citra nares ore ipso sternumento similem elidit sonum, per nares autem turbarum raucitati bubus tantum feminis vox gravior, in alio omni genere exilior quam maribus, in homine etiam castratis [270] infantis in nascendo nulla auditur ante quam totus emergat utero |
Come si è detto, per le rane, del proprio genere, a meno che non ci sia un dubbio da considerare in queste cose, perché la voce è prodotta nella bocca, non nel petto Tuttavia su esse incide molto anche la natura dei luoghi: sono tramandate mute in Macedonia, muti anche i cinghiali [268] Più canori degli uccelli quelli più piccoli, e soprattutto verso l'accoppiamento: per gli altri la voce durante la lotta, come per le pernici, per altri quando hanno vinto, come per i gallinacei Per questi maschi i propri (suoni), per altri gli stessi anche per le femmine, come per il genere degli usignoli Alcuni cantano tutto l'anno, alcuni in certi periodi, come è stato detto per ciascuno [269] L'elefante oltre dalle narici emette dalla bocca stessa un suono simile allo starnuto, attraverso le narici poi (uno) con la raucedine delle trombe Solo nei buoi più forte la voce per le femmine, in ogni altro genere più debole che nei maschi, nell'uomo anche nei castrati [270] Nella nascita del bambino non si sente nulla prima che esca tutto dall'utero |
| primus sermo anniculo; set semenstris locutus est Croesi filius et in crepundiis, prodigio quo totum id concidit regnum qui celerius fari coepere, tardius ingredi incipiunt vox roboratur a XIIII annis; eadem in senecta exilior, neque in alio animalium saepius mutatur Mira praeterea sunt de voce digna dictu: theatrorum in orchestris scobe aut harena superiacta devoratur, item rudi parietum circumiectu, doliis etiam inanibus currit eadem recto vel conchatum parietum spatio, quamvis levi sono dicta verba ad alterum caput perferens, si nulla inaequalitas impediat [271] vox in homine magnam voltus habet partem agnoscimus ea prius quam cernamus non aliter quam oculis, totidemque sunt hae, quot in rerum natura mortales, et sua cuique sicut facies |
Il primo discorso a un anno; ma parlò a sei mesi il figlio di Creso e ancora con i sonaglini, per un prodigio per cui cadde tutto questo regno Quelli che cominciano più velocemente a parlare, iniziano più tardi a camminare La voce s'irrobustisce dai quattordici anni; la stessa più esile in vecchiaia, e non si cambia più spesso in nessuno degli animali Inoltre riguardo alla voce ci sono fenomeni strani da raccontare: nelle orchestre dei teatri è assorbita dalla segatura o dalla sabbia sparsa, ugualmente nel rivestimento rude delle pareti, anche nelle botti vuote La stessa corre nello spazio dritto o delle pareti ricurve, portando all'altro capo le parole sebbene dette con suono lieve, se nessuna irregolarità impedisce [271] Nell'uomo la voce assume una grande parte dell'espressione Attraverso essa riconosciamo prima che vediamo non diversamente che con gli occhi, queste sono tante, quanti in natura i mortali, e a ciascuno la sua come il viso |
Maybe you might be interested
Plinio il Vecchio, Naturalis Historia: Libro 32, Paragrafi 01-63
Latino: dall'autore Plinio il Vecchio, opera Naturalis Historia parte Libro 32, Paragrafi 01-63
| hinc illa gentium totque linguarum toto orbe diversitas, hinc tot cantus et moduli flexionesque, sed ante omnia explanatio animi, quae nos distinxit a feris et inter ipsos quoque homines discrimen alterum, aeque quam a belvis, fecit [272] Membra animalibus adgnata inutilia sunt, sicut sextus homini semper digitus Placuit in Aegypto nutrire portentum, binis et in aversa capitis parte oculis hominem, sed iis non cernentem [273] Miror equidem Aristotelem non modo credidisse praescita vitae esse aliqua in corporibus ipsis, verum etiam prodidisse quae quamquam vana existimo nec sine cunctatione proferenda, ne in se quisque ea auguria anxie quaerat, attingam tamen, quia tantus vir in doctrinis non sprevit [274] igitur vitae brevis signa ponit raros dentes, praelongos digitos, plumbeum colorem pluresque in manu incisuras nec perpetuas |
Da qui quella diversità di popoli e di tante lingue in tutto il mondo, da qui tanti canti e ritmi e inflessioni, ma prima di tutto l'espressione del sentimento, che ci ha distinto dalle bestie e anche fra gli stessi uomini fece un'altra distinzione, ugualmente a quella dalle belve [272] Le membra nate in più sono inutili per gli animali, come sempre il sesto dito per gli uomini In Egitto piacque allevare un fenomeno, un uomo con due occhi nella parte posteriore del capo, ma che non vedeva con essi [273] Mi stupisco in verità che Aristotele non solo abbia creduto che nei corpi stessi ci siano alcuni pronostici della vita, ma anche averlo rivelato; ritengo queste cose sebbene vane da riferire non senza esitazione, affinché ciascuno non cerchi ansiosamente in sé questi presagi, tuttavia accennerò, perché un uomo tanto grande nelle dottrine non li ha disprezzati [274] Dunque reputa indizi di vita breve i denti rari, le dita molto lunghe, il colorito plumbeo e molte incisioni non continue sulla mano |
| contra longae esse vitae incurvos umeris et in manu unam aut duas incisuras longas habentes et plures quam XXXII dentes, auribus amplis nec universa haec, ut arbitror, sed singula observat, frivola, ut reor, et volgo tamen narrata addidit morum quoque spectus simili modo apud nos Trogus, et ipse auctor e severissimis, quos verbis eius subiciam: [275] Frons quibus est magna, segnem animum subesse significat; quibus parva, mobilem; quibus rotunda, iracundum, velut hoc vestigio tumoris apparente supercilia quibus porriguntur in rectum, molles significant; quibus iuxta nasum flexa sunt, austeros; quibus iuxta tempora inflexa, derisores; quibus in totum demissa, malivolos et invidos |
Al contrario essere di vita lunga i curvi di spalle e quelli che hanno sulla mano una o due fenditure lunghe e più di 32 denti, con orecchie grandi E non osserva, come penso, tutte queste cose insieme, ma singole, frivole, credo, tuttavia divulgate anche dalla gente Trogo, e egli stesso autore fra i più seri, presso di noi allo stesso modo ha aggiunto anche aspetti delle abitudini, che presenterò con le sue parole: [275] Per quelli a cui la fronte è grande, indica che c'è un animo pigro; per quelli a cui (è) piccola, volubile; per quelli a cui (è) rotonda, iracondo, ciò quasi come da un segno apparente di indignazione Per quelli a cui le sopracciglia sono protese diritte, si rivelano placidi; per quelli a cui sono piegate vicino al naso, severi; per quelli a cui piegate verso le tempie, ironici; per quelli a cui abbassate del tutto, malevoli e invidiosi |
Maybe you might be interested
Plinio il Vecchio, Naturalis Historia: Libro 14, Paragrafi 81-94
Latino: dall'autore Plinio il Vecchio, opera Naturalis Historia parte Libro 14, Paragrafi 81-94
| [276] oculi quibus utrimque sunt longi, malificos moribus esse indicant; qui carnosos a naribus angulos habent, malitiae notam praebent; candida pars extenta notam inpudentiae habet; qui identidem operiri solent, inconstantiae oricularum magnitudo loquacitatis et stultitiae nota est hactenus Trogus [277] Animae leonis virus grave, ursi pestilens contacta halitu eius nulla fera attingit, ociusque putrescunt adflata e reliquis homini tantum infici natura voluit pluribus modis, et ciborum ac dentium vitiis, sed maxime senio |
[276] Per quelli a cui ci sono occhi allungati da entrambe le parti, indicano essere malvagi nelle abitudini; quelli che hanno carnosi gli angoli verso le narici, mostrano traccia di malizia; la parte bianca estesa ha una traccia d'impudenza; quelli che sono soliti chiuderli ripetutamente, d'incostanza La grandezza delle orecchie è segno di loquacità e stoltezza Fin qua Trogo [277] Pesante il fetore del fiato del leone, pestilenziale (quello) dell'orso Nessuna bestia tocca le cose contaminate dal suo fiato, e quelle raggiunte dal fiato imputridiscono più velocemente Fra i rimanenti solo per l'uomo la natura ha voluto essere contaminata in molti modi, anche con le alterazioni dei cibi e dei denti, ma soprattutto nella vecchiaia |
| dolorem sentire non poterat, tactu sensuque omni carebat sine qua nihil sentitur; eadem commeabat recens assidue, exitura supremo et sola ex homine superfutura, denique haec trahebatur e caelo: [278] huius quoque tamen reperta poena est, ut neque id ipsum, quo vivitur, in vita iuvaret Parthorum populis haec praecipue et a iuventa propter indiscretos cibos, namque et vino faetent ora nimio; sed sibi proceres medentur grano Assyrii mali, cuius et suavitas praecipua, in esculenta addito |
(L'alito) non poteva sentire dolore, e mancava del tatto e di ogni senso senza cui non si prova niente; lo stesso andava e veniva costantemente nuovo, per uscire alla fine e il solo a sopravvivere fra le cose umane, infine questo era derivato dal cielo: [278] tuttavia è stata trovata una punizione anche di questo, affinché quello stesso per cui si vive, non giovasse nella vita Questo particolarmente per i popoli dei Parti e dalla giovinezza a causa di cibi indigesti, infatti le bocche puzzano anche per il troppo vino; ma i più grandi si curano da soli col seme della mela assiria, di cui anche una straordinaria dolcezza, in aggiunta commestibile |