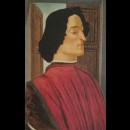| Plena exemplorum est nostra res publica cum saepe, tum maxime bello Punico secundo, quae Cannensi calamitate accepta maiores animos habuit quam unquam rebus secundis; nulla timoris significatio, nulla mentio pacis Tanta vis est honesti, ut speciem utilitatis obscuret Athenienses cum Persarum impetum nullo modo possent sustinere statuerentque, ut urbe relicta, coniugibus et liberis Troezene depositis, naves conscenderent libertatemque Graeciae classe defenderent, Cyrsilum quendam suadentem, ut in urbe manerent Xerxemque reciperent, lapidibus obruerunt Atque ille utilitatem sequi videbatur, sed ea nulla erat repugnante honestate |
Il nostro Stato è pieno di frequenti esempi in molte occasioni e specialmente nella seconda guerra punica: dopo la disfatta di Canne mostrò un coraggio maggiore di quanto ne avesse dimostrato nei periodi favorevoli; nessun segno di timore, nessuna parola di pace La forza dell'onesto è tale da oscurare l'apparenza dell'utilità Quando gli Ateniesi non erano in grado di sostenere l'assalto dei Persiani e stabilirono di abbandonare la città, dopo aver lasciato le mogli e i figli a Trezene, e di salire sulle navi per difendere con la flotta la libertà della Grecia, lapidarono un certo Cirsilo, che li invitava a rimanere in città e ad accogliere Serse Sembrava che egli avesse come obiettivo l'utilità, ma essa era inesistente, perché l'onestà le si opponeva |
| Themistocles post victoriam eius belli, quod cum Persis fuit, dixit in contione se habere consilium rei publicae salutare, sed id sciri non opus esse; postulavit, ut aliquem populus daret, quicum communicaret; datus est Aristides Huic ille, classem Lacedaemoniorum, quae subducta esset ad Gytheum, clam incendi posse quo facto frangi Lacedaemoniorum opes necesse esset Quod Aristides cum audisset, in contionem magna exspectatione venit dixitque perutile esse consilium, quod Themistocles adferret, sed minime honestum Itaque Athenienses, quod honestum non esset, id ne utile quidem putaverunt totamque eam rem, quam ne audierant quidem, auctore Aristide repudiaverunt Melius hi quam nos, qui piratas immunes, socios vectigales habemus |
Temistocle, dopo la vittoria nella guerra contro i Persiani, disse nell'assemblea di avere un consiglio salutare per lo Stato, ma che non era opportuno venisse conosciuto: chiese che il popolo gli desse qualcuno da rendere partecipe di tale consiglio: venne designato Aristide Egli gli disse che si poteva incendiare di nascosto la flotta spartana, all'ancora a Giteo, cosa che avrebbe inevitabilmente infranto le risorse degli Spartani Dopo che Aristide ebbe udito ciò, si recò nell'assemblea tra l'aspettazione generale e disse che il consiglio di Temistocle era utilissimo ma per nulla onesto Così gli Ateniesi non ritennero neanche utile ciò che non era onesto e dietro consiglio di Aristide rifiutarono un progetto che neppure conoscevano Meglio essi di noi, che lasciamo sani e salvi i pirati e riscuotiamo tributi dagli alleati |
| Maneat ergo, quod turpe sit, id numquam esse utile, ne tum quidem, cum id, quod utile esse putes, adipiscare; hoc enim ipsum, utile putare quod turpe sit, calamitosum est Sed incidunt, ut supra dixi, saepe causae, cum repugnare utilitas honestati videatur, ut animadvertendum sit, repugnetque plane an possit cum honestate coniungi Eius generis hae sunt quaestiones: Si exempli gratia vir bonus Alexandrea Rhodum magnum frumenti numerum advexerit in Rhodiorum inopia et fame summaque annonae caritate, si idem sciat complures mercatores Alexandrea solvisse navesque in cursu frumento onustas petentes Rhodum viderit, dicturusne sit id Rhodiis an silentio suum quam plurimo venditurus |
Sia ben chiaro, dunque, che quanto è immorale non può mai essere utile, neppure quando si consegue ciò che si crede utile; è, difatti, dannoso persino lo stimare utile ciò che è immorale Ma, come ho detto sopra, vi sono dei casi in cui l'utilità sembra in conflitto con l'onestà, cosicchè occorre considerare se sia veramente in contrasto o possa venire identificata con l'onestà Ecco i problemi di questo tipo: se, per esempio, un uomo onesto avesse importato da Alessandria a Rodi una grande quantità di frumento in un periodo di miseria e di carestia dei Rodiesi e di prezzi altissimi, e venisse a sapere che parecchi mercanti sono salpati da Alessandria e, lungo la rotta, avesse visto navi cariche di frumento dirigersi verso Rodi, dovrebbe dirlo ai Rodiesi o, tacendo, dovrebbe vendere al prezzo più alto il suo frumento |
Maybe you might be interested
Cicerone, De officiis: Libro 01 - Parte 01
Latino: dall'autore Cicerone, opera De officiis parte Libro 01 - Parte 01
| Sapientem et bonum virum fingimus; de eius deliberatione et consultatione quaerimus, qui celaturus Rhodios non sit, si id turpe iudicet, sed dubitet, an turpe non sit In huiusmodi causis aliud Diogeni Babylonio videri solet, magno et gravi Stoico, aliud Antipatro, discipulo eius, homini acutissimo; Antipatro omnia patefacienda, ut ne quid omnino, quod venditor norit, emptor ignoret, Diogeni venditorem, quatenus iure civili constitutum sit, dicere vitia oportere, cetera sine insidiis agere et, quoniam vendat, velle quam optime vendere Advexi, eui, vendo meum non pluris, quam ceteri, fortasse etiam minoris, cum maior est copia; cui fit iniuria Exoritur Antipatri ratio ex altera parte: Quid ais |
Immaginiamo un uomo saggio e onesto e ci poniamo il problema delle decisioni e delle considerazioni di lui, che non vorrebbe lasciare all'oscuro i Rodiesi, se ritenesse ciò un'azione vergognosa, ma potrebbe essere in dubbio se la cosa sia deprecabile o no In casi simili diversa è l'opinione di Diogene di Babilonia, stoico importante e serio, e di Antipatro, suo discepolo, uomo di straordinaria acutezza: secondo Antipatro bisogna dichiarare tutto, perché il compratore non ignori nulla che sia noto al venditore; secondo Diogene occorre che il venditore riveli i difetti, limitatamente alle prescrizioni del diritto civile, tratti il resto senza frode e, dal momento che vende, cerchi di vendere al prezzo più vantaggioso Ho importato la merce, l'ho esposta, la vendo a un prezzo non maggiore degli altri, forse anche minore, poiché ne ho una quantità più grande: A chi faccio torto Insorge dall'altra parte il ragionamento di Antipatro: Che dici |
| tu, cum hominibus consulere debeas et servire humanae societati eaque lege natus sis et ea habeas principia naturae, quibus parere et quae sequi debeas, ut utilitas tua communis sit utilitas vicissimque communis utilitas tua sit, celabis homines, quid iis adsit commoditatis et copiae Respondebit Diogenes fortasse sic: Aliud est celare, aliud tacere, neque ego nunc te celo, si tibi non dico, quae natura deorum sit, qui sit finis bonorum, quae tibi plus prodessent cognita quam tritici vilitas Sed non, quicquid tibi audire utile est, idem mihi dicere necesse est Immo vero, inquiet ille necesse est, si quidem meministi esse inter homines natura coniunctam societatem Memini, inquiet ille, sed num ista societas talis est, ut nihil suum cuiusque sit Quod si ita est, ne vendendum quidem quicquam est, sed donandum |
Tu, che dovresti preoccuparti degli uomini e dedicarti alla società umana, tu che sei nato sotto questa legge ed hai questi principi naturali, ai quali devi obbedire e conformarti, e cioè che il tuo utile sia l'utile comune e per converso l'utile comune sia il tuo, tu nasconderai agli uomini il vantaggio e l'abbondanza che si presentano loro Diogene risponderà, forse, così: Una cosa è nascondere e un'altra tacere; e io non ti nascondo, adesso, se non te lo dico, quale sia la natura degli dei, quale il sommo bene, cose che, una volta conosciute, ti gioverebbero di più del sapere il basso prezzo dei grano Ma non è necessario che io ti dica tutto ciò che a te è utile ascoltare Anzi, ríbatterà quello, è necessario, se pure ti ricordi che tra gli uomini c'è, per natura, un vincolo sociale Me ne ricordo, dirà l'altro, ma questa società è forse tale che nulla appartenga più privatamente a ciascuno Se cosi fosse, non bisognerebbe neppure vender nulla, ma donare |
Maybe you might be interested
Cicerone, De officiis: Libro 01 - Parte 04
Latino: dall'autore Cicerone, opera De officiis parte Libro 01 - Parte 04
| Vides in hac tota disceptatione non illud dici quamvis hoc turpe sit, tamen, quoniam expedit, faciam, sed ita expedire, ut turpe non sit, ex altera autem parte, ea re, quia turpe sit, non esse faciendum Vendat aedes vir bonus, propter aliqua vitia, quae ipse norit, ceteri ignorent, pestilentes sint et habeantur salubres, ignoretur in omnibus cubiculis apparere serpentes, sint, male materiatae et ruinosae, sed hoc praeter dominum nemo sciat; quaero, si haec emptoribus venditor non dixerit aedesque vendiderit pluris multo quam se venditurum putarit, num id iniuste aut improbe fecerit Ille vero inquit Antipater Quid est enim aliud erranti viam non monstrare, quod Athenis execrationibus publicis sanctum est, si hoc non est, emptorem pati ruere et per errorem in maximam fraudem incurrere |
Puoi constatare che in tutta questa discussione non si dice: benché ciò sia vergognoso, pure, dal momento che è utile, lo farò ma da parte dell'uno che è utile così da non essere vergognoso, da parte dell'altro che non si deve fare perché è immorale Un galantuomo vende una casa per dei difetti a lui noti e ignoti agli altri; la casa è malsana ma la si ritiene salubre, si ignora che in tutte le stanze saltano fuori dei serpenti, è costruita con materiale cattivo ed è in sfacelo, ma tutto questo non lo sa nessuno, tranne il padrone; io chiedo: se il venditore non dicesse questo ai compratori e vendesse la casa ad un prezzo molto più alto di quanto si sarebbe aspettato, compirebbe un'azione ingiusta e disonesta Certo dice Antipatro Che altro è il non indicare la via a chi sta vagando cosa punita in Atene con la pubblica esecrazione se non questo, lasciare che il compratore agisca sconsideratamente e per questo errore cada in una gravissima frode |
| Plus etiam est quam viam non monstrare; nam est scientem in errorem alterum inducere Diogenes contra Num te emere coegit, qui ne hortatus quidem est Ille, quod non placebat, proscripsit, tu quod placebat, emisti Quod si qui proscribunt villam bonam beneque aedificatam non existimantur fefellisse, etiam si illa nec bona est nec aedificata ratione, multo minus, qui domum non laudarunt Ubi enim iudicium emptoris est, ibi fraus venditoris quae potest esse Sin autem dictum non omne praestandum est, quod dictum non est, id praestandum putas Quid vero est stultius quam venditorem eius rei, quam vendat, vitia narrare Quid autem tam absurdum quam si domini iussu ita praeco praedicet: domum pestilentem vendo |
E', anzi, di più che il non mostrare la strada, perché è indurre E Diogene di rimando: Ti ha costretto forse a comprare, chi non ti ha neanche esortato a farlo Quello l'ha messa in vendita, perché non gli piaceva, tu l'hai comprata, perché ti piaceva Se quanti mettono in vendita una villa come bella e ben costruita non vengono ritenuti frodatori, anche se la villa non è né bella né ben costruita, molto meno dovrebbero esserlo considerati coloro che non hanno decantato i pregi della casa Quando, difatti, la decisione è lasciata al compratore, quale potrebbe essere la frode del venditore Se, poi, non bisogna mantenere tutto quello che è stato detto espressamente, pensi che si debba mantenere ciò che non è stato detto espressamente E che c'è, poi, di più sciocco del fatto che il venditore elenchi i difetti della sua merce e che cosa di più assurdo, se il banditore, per ordine del padrone, andasse gridando: vendo una casa malsana |
Maybe you might be interested
Cicerone, De officiis: Libro 03 - Parte 02
Latino: dall'autore Cicerone, opera De officiis parte Libro 03 - Parte 02
| Sic ergo in quibusdam causis dubiis ex altera parte defenditur honestas, ex altera ita de utilitate dicitur, ut id, quod utile videatur, non modo facere honestum sit, sed etiam non facere turpe Haec est illa, quae videtur utilium fieri cum honestis saepe dissensio Quae diiudicanda sunt; non enim, ut quaereremus, euimus, sed ut explicaremus Non igitur videtur nec frumentarius ille Rhodios nec hic aedium venditor celare emptores debuisse Neque enim id est celare, quicquid reticeas, sed cum, quod tu scias, id ignorare emolumenti tui causa velis eos, quorum intersit id scire Hoc autem celandi genus quale sit et cuius hominis, quis non videt Certe non aperti, non simplicis, non ingenui, non iusti, non viri boni, versuti potius obscuri, astuti, fallacis, malitiosi, callidi, veteratoris, vafri Haec tot et alia plura nonne inutile est vitiorum subire nomina |
Così, dunque, in taluni casi dubbi da una parte si difende l'onestà, dall'altra si parla dell'utile in modo tale che non solo è onesto fare, ma anzi è vergognoso non fare quanto sembra utile E' questo il conflitto che sembra sorgere frequentemente tra l'utile e l'onesto Bisogna risolvere questi casi, che abbiamo esposti non per porre domande, ma per poterli spiegare Non sembra che né quel mercante di grano ai Rodiesi né questo venditore della casa agli acquirenti avrebbero dovuto nascondere nulla Nascondere non significa, difatti, tacere tutto ciò che sai, ma volere che ignorino quello che tu sai, per tuo guadagno, quanti avrebbero interesse a saperlo Chi non vede quale sia e caratteristico di quale uomo questo modo di celare Certo non è proprio di un uomo leale, schietto, nobile, giusto, buono, ma piuttosto di un uomo scaltro, dissimulatore, astuto, ingannatore, malizioso, sagace, furbacchione ed abile Che utilità c'è a tirarsi addosso tanti ed altri ancor più numerosi appellativi di difetti |
| Quod si vituperandi qui reticuerunt, quid de iis existimandum est, qui orationis vanitatem adhibuerunt C Canius, eques Romanus, nec infacetus et satis litteratus, cum se Syracusas otiandi, ut ipse dicere solebat, non negotiandi causa contulisset, dictitabat se hortulos aliquos emere velle, quo invitare amicos et ubi se oblectare sine interpellatoribus posset Quod cum percrebuisset, Pythius ei quidam, qui argentariam faceret Syracusis, venales quidem se hortos non habere, sed licere uti Canio, si vellet, ut suis, et simul ad cenam hominem in hortos invitavit in posterum diem Cum ille promisisset, tum Pythius, qui esset ut argentarius apud omnes ordines gratiosus, piscatores ad se convocavit et ab iis petivit, ut ante suos hortulos postridie piscarentur, dixitque quid eos facere vellet |
E se è da biasimare chi tace, come devono esser giudicati quanti sono soliti servirsi di discorsi ingannevoli Gaio Genio, cavaliere romano, uomo non privo di spirito e abbastanza colto, essendosi recato a Siracusa per trascorrervi un periodo di vacanza, come lui stesso era solito dire, e non per e oncludere af fari, andava dicendo di voler comprare una villetta dove potesse invitare gli amici e divertirsi senza essere disturbato da importuni Essendosi diffusa la notizia, un certo Pizio, banchiere a Siracusa, gli disse che non aveva ville da vendere, ma che Canio poteva servirsi della sua, se voleva, come se gli appartenesse, e contemporaneamente lo invitò a cena in villa per il giorno dopo Avendogli Canio promesso di venire, Pizio che, in qualità di banchiere, godeva credito presso tutte le categorie di persone, chiamò a sé dei pescatori, chiese loro di pescare il giorno dopo di fronte alla sua villa, e disse quanto desiderava che essi facessero |
Maybe you might be interested
Cicerone, De officiis: Libro 01 - Parte 03
Latino: dall'autore Cicerone, opera De officiis parte Libro 01 - Parte 03
| Ad cenam tempori venit Canius; opipare a Pythio adparatum convivium, cumbarum ante oculos multitudo, pro se quisque, quod ceperat, adferebat; ante pedes Pythii pisces abiciebantur Tum Canius quaeso, inquit, quid est hoc, Pythi tantumne piscium tantumne cumbarum Et ille: Quid mirum inquit, hoc loco est Syracusis quidquid est piscium, hic aquatio, hac villa isti carere non possunt Incensus Canius cupiditate contendit a Pythio, ut venderet Gravate ille primo Quid multa Impetrat : Emit homo cupidus et locuples tanti, quanti Pythius voluit, et emit instructos ; nomina facit, negotium conficit Invitat Canius postridie familiares suos, venit ipse mature, scalmum nullum videt Quaerit ex proximo vicino, num feriae quaedam piscatorum essent, quod eos nullos videret |
Canio venne puntualmente per la cena; il banchetto era stato imbandito puntualmente da Pizio, davanti agli occhi si presentava una moltitudine di barche e ogni pescatore portava, a turno, ciò che aveva preso; i pesci venivano gettati ai piedi di Pizio Allora Canio: Di grazia disse E quello, disse Tutti i pesci di Siracusa stanno qui, qui vengono a rifornirsi d'acqua, non possono fare a meno di questa villa Canio, preso dal desiderio, chiese insistentemente a Pizio che gli vendesse la villa Sulle prime quello faceva il difficile Che motivo c'è di dilungarsi Ottiene il suo scopo: quell'uomo bramoso e ricco compra la villa al prezzo richiesto da Pizio e la compra con tutto l'arredamento, registra la vendita e l'affare è concluso Canio invita il giorno dopo i suoi amici; arriva per tempo, ma non vede neanche una barca Chiese al vicino più prossimo se ci fossero festività dei pescatori, dato che non ne vedeva nessuno |