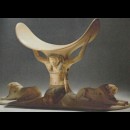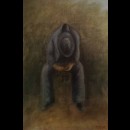| [21]spectare oliveta in favonium loco exposito solibus censet, nec alio ullo modo laudat condi olivas optime orchites et posias, vel virides in muria vel fractas in lentisco oleum quam acerbissima oliva optimum fieri cetero quam primum e terra colligendam, si inquinata sit, lavandam; siccari triduo satis esse si gelent frigora, quarto die premendam; hanc et sale aspergi oleum in tabulato minui deteriusque fieri, item in amurca et fracibus ( hae sunt carnes et inde faeces); [22]quare saepius die capulandum, praeterea concha et in plumbeas cortinas; aere vitiari ferventibus omnia ea fieri clausisque torcularibus et quam minime ventilatis, ideo nec ligna ibi caedi oportere: qua de causa e nucleis ipsarum ignis aptissimus; ex cortinis in labra fundendum, ut fraces et amurca linquantur |
[21] Pensa che gli oliveti guardino verso il favonio in un luogo esposto ai raggi, e non approva altro in alcun modo (Dice) che le olive orchites e posia si conservano ottimamente, o verdi in salamoia o tritate nel lentisco Che dall'oliva quanto più acerba si ottiene olio ottimo Per il resto che bisogna raccoglierla quanto prima da terra e lavarla, se è sporca; che si secca abbastanza in tre giorni Se i freddi la gelano, deve essere spremuta nel quarto giorno; che questa viene cosparsa anche col sale Che l'olio diventa meno abbondante e più scadente sui ripiani, ugualmente con la morchia e le fecce (queste sono polpe e poi fecce); [22] Per questo va travasato più volte al giorno, inoltre con un recipiente a forma di conchiglia e in caldaie di piombo; viene rovinato dal rame Che tutte queste cose si fanno in frantoi caldi e chiusi e quanto meno ventilati, che perciò lì non serve che sia tagliata la legna: per questo scopo adattissimo il fuoco dei noccioli delle stesse (olive); dalle caldaie va versato in vasi, affinché siano lasciate fecce e morchia |
| ob id crebrius vasa mutanda, fiscinas spongia tergendas, ut quam maxime pura sinceritas constet [23]postea inventum ut lavarentur utique ferventi aqua, protinus prelo subicerentur solidae ita enim amurca exprimitur, mox trapetis fractae premerentur iterum premi plus quam centenos modios non probant: factus vocatur; quod vero post molam primum expressum est, flos factus tres gemino foro a quaternis hominibus nocte et die premi iustum est [24]Non erat tum ficticium oleum, ideoque arbitror de eo nihil a Catone dictum nunc eius genera plura, primumque persequemur ea quae ex arboribus fiunt, et inter illas ante omnes ex oleastro tenue id multoque amarius quam oleae et tantum ad medicamenta utile simillimum huic est ex chamelaea, frutice saxoso, non altiore palmo, foliis oleastri bacisque |
Per questo più spesso si devono cambiare i vasi, pulire le ceste con la spugna, affinché la genuinità risulti pura al massimo [23] Poi si è pensato affinché fossero lavate comunque con acqua calda, fossero messe intere subito sul torchio -infatti così è spremuta la morchia-, poi macinate nei frantoi fossero spremute di nuovo Non consigliano che siano spremuti più di cento moggi: è chiamato macinato; invece quello che è premuto dopo la prima pressatura, fiore E' normale che in una notte e un giorno siano spremuti tre macinati da quattro uomini su due piattaforme [24] Non c'era allora olio adulterato, perciò penso che nulla sia stato detto su ciò da Catone Ora diversi i suoi generi, innanzitutto tratteremo quelli che derivano dagli alberi, e fra quelli prima di tutti dall'oleastro Questo leggero e di molto più amaro che quello dell'olivo, e utile solo per i medicinali Molto simile a questo è (quello derivato) dalla camelea, con un arbusto rupestre, non più alto di un palmo, con foglie e bacche dell'oleastro |
| [25]proximum fit e cici, arbore in Aegypto copiosa (alii crotonem, alii sibi, alii sesamon silvestre eam appellant), ibique, non pridem et in Hispania, repente provenit altitudine oleae, caule ferulaceo, folio vitium, semine uvarum gracilium pallidarumque nostri eam ricinum vocant a similitudine seminis coquitur id in aqua, innatansque oleum tollitur at in Aegypto, ubi abundat, sine igni et aqua sale adspersum exprimitur, cibis foedum, lucernis exile [26]amygdalinum, quod aliqui neopum vocant, ex amaris nucibus arefactis et in offam contusis adspersam aqua iterumque tusis exprimitur fit et lauru admixto drupparum oleo, quidamque e bacis exprimunt tantum, alii foliis modo, aliqui folio et cortice bacarum, nec non styracem adunt aliosque odores; optima laurus ad id latifolia, silvestris, nigris bacis |
[25] Il seguente deriva dal cici, albero frequente in Egitto (alcuni lo chiamano crotone, altri sibi, altri sesamo selvatico), e qui, non da molto anche in Spagna, cresce velocemente con altezza dell'olivo, con un fusto sottile, la foglia delle viti, col seme delle uve gracili e chiare I nostri lo chiamano ricino per la somiglianza del seme Questo viene cotto in acqua, e si raccoglie l'olio che galleggia Invece in Egitto, dove abbonda, è spremuto senza fuoco e acqua cosparso col sale, disgustoso per i cibi, fioco per le lucerne [26] Quello di mandorla, che alcuni chiamano neopum, si estrae dalle noci amare seccate e pestate in un impasto bagnato con acqua e di nuovo spremute Si fa anche dall'alloro mischiato con olio di drupe, alcuni l'estraggono solo dalle bacche, altri solo dalle foglie, alcuni dalla foglia e dalla corteccia delle bacche, e non tralasciano lo storace ed altri odori; ottimo per questo il lauro a foglia larga, selvatico, con bacche nere |
Maybe you might be interested
Plinio il Vecchio, Naturalis Historia: Libro 07, Paragrafi 17 - 33
Latino: dall'autore Plinio il Vecchio, opera Naturalis Historia parte Libro 07, Paragrafi 17 - 33
| [27]simile est et e myrto nigra, et haec latifolia melior tunduntur bacae adspersae calida aqua, mox decoquuntur alii foliorum mollissima decoquunt in oleo et exprimunt, alii deiecta ea in oleum prius sole maturant eadem ratio et in sativa myrto, sed praefertur silvestris minore semine, quam quidam oxymyrsinen, alii chamaemyrsinen vocant, aliqui acoron a similitudine; est enim brevis, fruticosa [28]fit et e citro, cupresso, nucibus iuglandibus quod caryinum vocant, malis, cedro quod pisselaeon, e grano quoque Cnidio purgato semine et tunso, item lentisco nam cyprinum et e glande Aegyptia ut fieret odorum causa dictum est Indi e castaneis ac sesima atque oryza facere dicuntur, Ichthyophagi e piscibus [29]inopia cogit aliquando luminum causa et e platani bacis fieri aqua et sale maceratis |
[27] E' simile anche quello dal mirto nero, e questo migliore a foglia larga Le bacche spruzzate con acqua calda sono pestate, poi vengono cotte Alcuni cucinano le foglie più tenere nell'olio e le spremono, altri fanno maturare prima al sole queste gettate nell'olio Lo stesso metodo anche nel mirto coltivato, ma si preferisce il selvatico per il seme più piccolo, che alcuni chiamano pungitopo, altri mirto silvestre, alcuni acoro per la somiglianza; infatti è basso, cespuglioso [28] Si ottiene anche dal limone, dal cipresso, da alberi di noci che chiamano nocino, dai meli, dal cedro che (chiamano) olio di pece, anche dal grano di Cnido pulito del seme e schiacciato, ugualmente dal lentisco Infatti si è detto a causa dei profumi come si ottenesse il ciprino e quello dalla ghianda d'Egitto Si dice che gli Indi lo facciano dalle castagne e dal sesamo e dal riso, gli Ittiofagi dai pesci [29] La mancanza costringe talvolta a farne a causa delle lucerne anche dalle bacche del platano macerate in acqua e sale |
| et oenanthinum fit; de ipsa oenanthe dictum est in unguentis gleucino mustum incoquitur vapore lento, ab aliis sine igni circumdatis vinaceis diebus XXI bis singulis permixtum, consumiturque mustum oleo aliqui non sampsuchum tantum admiscent, sed etiam pretiosiora odoramenta, ut in gymnasiis quoque conditur odoribus, sed vilissimis [30]fit ex aspalatho, calamo, balsamo, iri, cardamomo, meliloto, nardo Gallico, panace, sampsucho, helenio, cinnamomi radice, omnium sucis in oleo maceratis expressisque sic et rhodinum e rosis, iuncinum et iunco, quod et rosaceo simillimum, item hyoscyamo et lupinis, narcisso plurimum autem in Aegypto e raphani semine aut gramine herba quod chortinon vocant, item e sesima et urtica quod cnidinum appellant [31]e lilio et alibi fit sub diu sole, luna, pruina maceratum |
Si fa anche quello di enante; dell'enante stessa si è detto a proposito dei profumi Per il gleucino si cuoce il mosto col vapore tiepido, da altri senza fuoco dopo aver messo intorno vinacce per ventun giorni rimescolato due volte al giorno, e il mosto viene consumato dall'olio Altri mischiano non solo la maggiorana, ma anche aromi più preziosi, cosicché anche nelle palestre è temperato con odori, ma di pochissimo valore [30] Si ricava dall'aspalato, dal calamo, dal balsamo, dal giaggiolo, dal cardamomo, dal meliloto, dal nardo gallico, dalla panacea, dalla maggiorana, dall'elenio, dalla radice di cinnamomo, dopo aver macerato i succhi di tutti nell'olio e spremuti Così anche il rodino dalle rose, olio di giunco dal giunco, che anche molto simile a quello di rosa, così dal giusquiamo e dai lupini, dal narciso In Egitto poi moltissimo dal seme di rafano o dall'erba gramigna che chiamano chortinon, ancora dal sesamo e dall'ortica che chiamano cnidino [31] Altrove si ottiene anche dal giglio macerato a lungo sotto il sole, la luna, le brine |
Maybe you might be interested
Plinio il Vecchio, Naturalis Historia: Libro 18, Paragrafi 70-123
Latino: dall'autore Plinio il Vecchio, opera Naturalis Historia parte Libro 18, Paragrafi 70-123
| suis herbis componunt inter Cappadociam et Galatiam quod Selgiticum vocant, nervis admodum utile, sicut in Italia Iguvini e pice fit quod pissinum appellant, cum coquitur, velleribus supra halitum eius expansis atque ita expressis probatum maxime e Bruttia; est enim pinguissima et resinosissima [32]color oleo fulvus sponte nascitur in Syriae maritimis quod elaeomeli vocant; manat ex arboribus pingue, crassius melle, resina tenuius, sapore dulci, et hoc medicis veteri quoque oleo usus est ad quaedam genera morborum; existimaturque et ebori vindicando a carie utile esse: certe simulacrum Saturni Romae intus oleo repletum est [33]Super omnia vero celebravit amurcam laudibus Cato |
Fra la Cappadocia e la Galazia con le loro erbe fanno quello che chiamano selgitico, assai utile per i tendini, come (fanno) in Italia gli Iguvini Dalla pece si ottiene quello che chiamano olio di pece, con pelli stese sopra il suo vapore, quando viene cotto, e così spremute Soprattutto apprezzato quello dalla pece del Bruzio; infatti è molto grassa e molto resinosa [32] Rosso il colore per l'olio Nasce spontaneamente nelle zone costiere della Siria quello che chiamano gomma dell'olivo; cola grasso dagli alberi, più denso del miele, più sottile della resina, di sapore dolce, anche questo per i medici Anche per l'olio vecchio c'è l'utilizzo verso certi tipi di mali; ed è ritenuto essere anche utile per l'avorio da proteggere dalla corrosione: certo a Roma la statua di Saturno è stata riempita di olio [33] Invero sopra tutte le cose Catone celebrò la morchia |
| dolia olearia cadosque illa imbui, ne bibant oleum; amurca subigi areas terendis messibus, ut formicae rimaeque absint; quin et luteum parietum ac tectoria et pavimenta horreorum frumenti, vestiaria etiam contra teredines ac noxia animalium amurca aspergi, semina frugum perfundi morbis quadripedum, arborum quoque, illa medendum, efficaci ad ulcera interiora humani quoque oris [34]lora etiam et coria omnia et calceamina axesque decocta ungui atque aeramenta contra aeruginem colorisque gratia elegantioris et totam supellectilem ligneam ac vasa fictilia, in quis ficum aridam libeat adservare, aut si folia bacasque in virgis myrti aliudve quod genus simile postremo ligna macerata amurca nullo fumi taedio ardere oleam si lambendo capra lingua contigerit depaveritque primo germinatu, sterilescere auctor est M Varro |
(Dice che) botti per l'olio e orci sono riempiti di quella, affinché non assorbano olio; che le aie sono intrise di morchia per le messi da tritare, affinché siano assenti formiche e fessure; anzi anche l'argilla dei muri e i tetti e i pavimenti dei depositi di grano, sono spruzzati anche gli abiti contro i tarli e i danni degli insetti, i semi dei cereali Con quella si curano le malattie degli animali, anche degli alberi, efficace anche per le ferite interne della bocca dell'uomo [34] (Dice che) vengono unte con quella cotta anche le cinghie e tutti gli oggetti di cuoio e le calzature e gli assi e gli oggetti di rame contro la ruggine e per un colore più vivace e ogni suppellettile di legno e i vasi di coccio, in cui si gradisce conservare il fico secco, o anche le foglie e le bacche sugli steli del mirto o qualche altro genere simile Infine che i legni macerati con la morchia bruciano senza fastidio del fumo Se una capra leccando avrà toccato con la lingua e avrà brucato un olivo con il primo germoglio, M Varrone sostiene che diventa sterile |
Maybe you might be interested
Plinio il Vecchio, Naturalis Historia: Libro 04, Paragrafi 75-80
Latino: dall'autore Plinio il Vecchio, opera Naturalis Historia parte Libro 04, Paragrafi 75-80
| et hactenus de olea atque oleo [35]Reliqui arborum fructus vix specie figurave, non modo saporibus sucisque totiens permixtis atque insitis, enumerari queunt Grandissimus pineis nucibus altissimeque suspensus intus exiles nucleos lacunatis includit toris, vestitos alia ferruginis tunica, mira naturae cura molliter semina conlocandi harum genus alterum Tarentinae digitis fragili putamine aviumque furto in arbore [36]et tertium sappini e picea sativa, nucleorum cute verius quam putamine adeo molli, ut simul mandatur quartum pitydia vocant e pinastris, singularis remedii adversus tussim in melle decoctis nucleis Taurini ravicelos vocant pinea corona victores apud Isthmum coronantur |
E fin qui riguardo all'olivo e all'olio [35] Gli altri frutti degli alberi possono essere numarati a stento secondo la specie e la forma, non solo per i sapori e i succhi tante volte mescolati ed innestati Molto grande e sospeso molto in alto per le pigne Dentro racchiude pinoli sottili in ripari incavati, rivestiti di un'altra membrana color ferro, mirabile la cura della natura di collocare delicatamente i semi Un'altra specie di queste quella della tarentina con scorza fragile per le dita e come preda degli uccelli sull'albero [36] E la terza (quella) della sappinia dalla picea coltivata, con una membrana dei pinoli più che una scorza, tanto tenera che viene anche mangiata Chiamano pitidia una quarta dal pinastro, di singolare rimedio contro la tosse con i pinoli cotti nel miele I Taurini li chiamano raviceli Presso l'Istmo i vincitori sono incoronati con una corona di pino |