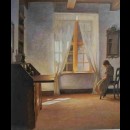| Quae si ex eo quod plures faciunt nomen accipiat, periculosissimum dabit praeceptum non orationi modo sed, quod maius est, vitae: unde enim tantum boni ut pluribus quae recta sunt placeant Igitur ut velli et comam in gradus frangere et in balneis perpotare, quamlibet haec invaserint civitatem, non erit consuetudo, quia nihil borum caret reprensione (at lavamur et tondemur et convivimus ex consuetudine), sic in loquendo non si quid vitiose multis insederit pro regula sermonis accipiendum erit; Nam ut transeam quem ad modum vulgo imperiti loquantur, tota saepe theatra et omnem circi turbam exclamasse barbare scimus Ergo consuetudinem sermonis vocabo consensum eruditorum, sicut vivendi consensum bonorum |
Se questa prende nome da ciò che i più fanno, fornirà un precetto pericolosissimo non solo al discorso ma, ciò che importa di più, alla vita: infatti da dove tanto vantaggio cosicché ai più piacciano quelle cose che sono giuste Dunque come depilarsi e dividere la chioma in trecce e continuare a bere alle terme, sebbene tali cose abbiano invaso la città, non sarà consuetudine, perché niente dei vantaggi manca di biasimo (ma ci laviamo e ci radiamo e facciamo conviti per consuetudine), così nel parlare non si dovrà accettare come regola del discorso se sarà imposta a molti qualcosa irregolarmente Infatti cosicché io tralasci come parlano al volgo gli inesperti, sappiamo che spesso tutti i teatri e ogni folla del circo hanno gridato barbaramente; dunque chiamerò consuetudine del linguaggio l'approvazione degli eruditi, come l'approvazione del vivere degli onesti |
| I Nunc, quoniam diximus quae sit loquendi regula, dicendum quae scribentibus custodienda, quod Graeci orthographian vocant, nos recte scribendi scientiam nominemus; cuius ars non in hoc posita est, ut noverimus quibus quaeque syllaba litteris constet (nam id quidem infra grammatici officium est), sed totam, ut mea fert opinio, subtilitatem in dubiis habet II ut longis syllabis omnibus adponere apicem ineptissimum est, quia plurimae natura ipsa verbi quod scribitur patent, sed interim necessarium, cum eadem littera alium atque alium intellectum, prout correpta vel producta est, facit III ut "malus" arborem significet an hominem non bonum apice distinguitur, "palus" aliud priore syllaba longa, aliud sequenti significat, et cum eadem littera nominativo casu brevis, ablativo longa est, utrum sequamur plerumque hac nota monendi sumus |
I Ora, poiché abbiamo detto quale sia la regola del parlare, bisogna dire quelle devono essere seguite da quelli che scrivono, che i Greci chiamano ortografia, noi definiamo la scienza dello scrivere correttamente; la cui arte non è inserita in ciò, affinché sappiamo di quali lettere risulti ciascuna sillaba (infatti ciò è certo un compito al di sotto di un grammatico), ma racchiude tutta la sottigliezza, come rivela il mio parere, nei casi dubbi II così è molto inadeguato mettere un apice a tutte le sillabe lunghe, perché molte per la natura stessa della parola mostrano ciò che si scrive, ma talvolta necessario, quando con la stessa lettera rende ora un significato ora un altro, in quanto è corta o lunga III affinché "malus" indichi l'albero o un uomo non buono è distinto da un apice, "palus" significa una cosa con la sillaba anteriore lunga, un'altra con quella che segue, e quando la stessa lettera è breve nel caso nominativo, lunga nell'ablativo, da questa indicazione dobbiamo essere guidati quale dei due generalmente seguiamo |
| IV Similiter putaverunt illa quoque servanda discrimina, ut "ex" praepositionem si verbum sequeretur "specto", adiecta secundae syllabae s littera, si "pecto", remota scriberemus V Illa quoque servata est a multis differentia, ut "ad", cum esset praepositio, d litteram, cum autem coniunctio, t acciperet, itemque "cum", si tempus significaret, per quom, si comitem, per c ac duas sequentis scriberetur VI Frigidiora his alia, ut "quidquid" c quartam haberet ne interrogare bis videremur, et "quotidie" non "cotidie", ut sit quot diebus: verum haec iam etiam inter ipsas ineptias evanuerunt VII Quaeri solet, in scribendo praepositiones sonum quem iunctae efficiunt an quem separatae observare conveniat, ut cum dico "optinuit" (secundam enim b litteram ratio poscit, aures magis audiunt p) |
IV Ugualmente considerarono doversi mantenere anche queste differenze, cosicché "specto" seguisse la preposizione "ex" se verbo, aggiunta la lettera s alla seconda sillaba, staccata se scrivessimo "pecto" V E' mantenuta da molti anche quella differenza, affinché "ad", quando è preposizione, prenderebbe la lettera d, invece quando congiunzione, la t, ugualmente si scriverebbe "cum", se indica il tempo, mediante quom, se compagnia, mediante c e due della lettera successiva VI Altre più fiacche di queste, cosicché "quidquid" abbia per quarta la c affinché non sembriamo interrogare due volte, e "quotidie" non "cotidie", affinché indichi per quanti giorni: ma ormai anche queste sono sparite fra le inezie stesse VII Suole essere chiesto, se nello scrivere le preposizioni convenga seguire il suono che producono unite o quello da separate, come quando dico "optinuit" (infatti la regola chiede seconda lettera la b, le orecchie sentono di più la p) |
Maybe you might be interested
Quintiliano, Institutio oratoria: Liber 1, 8, 1-12
Latino: dall'autore Quintiliano, opera Institutio oratoria parte Liber 1, 8, 1-12
| VIII et "immunis" (illud enim quod veritas exigit, sequentis syllabae sono victum, m gemina commutatur) IX Est et in dividendis verbis observatio, mediam litteram consonantem priori an sequenti syllabae adiungas; "Haruspex" enim, quia pars eius posterior a spectando est, s litteram tertiae dabit, "abstemius", quia ex abstinentia temeti composita vox est, primae relinquet X Nam k quidem in nullis verbis utendum puto nisi quae significat etiam ut sola ponatur; Hoc eo non omisi quod quidam eam quotiens a sequatur necessariam credunt, cum sit c littera, quae ad omnis vocalis vim suam perferat |
VIII e "immunis" (infatti la regola impone questo che, vinta dal suono della sillaba seguente, è cambiata in una doppia m) IX C'è anche la considerazione nelle parole da dividere, se aggiungi una lettera consonante centrale alla precedente o alla sillaba seguente; infatti "haruspex", poiché la sua parte seguente deriva da specto, darà la lettera s alla terza, "abstemius", poiché è una voce composta da astinenza del vino, lascerà alla prima X Infatti penso non doversi certo usare k in nessuna parola a meno che non indichi quelle cose affinché sia inserita anche da sola; Non ho qui tralasciato ciò poiché alcuni la ritengono necessaria per quante volte sia seguita dalla a, essendoci la lettera c, che incide secondo la forza propria di ogni vocale |
| XI Verum orthographia quoque consuetudini servit ideoque saepe mutata est; Nam illa vetustissima transeo tempora, quibus et pauciores litterae nec similes his nostris earum formae fuerunt et vis quoque diversa, sicut apud Graecos o litterae, quae interim longa ac brevis, ut apud nos, interim pro syllaba quam nomine suo exprimit posita est XII ut a Latinis veteribus d plurimis in verbis ultimam adiectam, quod manifestum est etiam ex columna rostrata, quae est duilio in foro posita, interim g quoque, ut in pulvinari Solis, qui colitur iuxta aedem Quirini, "vesperug", quod "vesperuginem" accipimus XIII De mutatione etiam litterarum, de qua supra dixi, nihil repetere hic necesse est: fortasse enim sicut scribebant, etiam loquebantur XIV Semivocalis geminare diu non fuit usitatissimi moris, atque e contrario usque ad Accium et ultra porrectas syllabas geminis, ut dixi, vocalibus scripserunt |
XI Certo anche l'ortografia serve alla consuetudine e perciò spesso viene cambiata; infatti tralascio quei tempi antichissimi, in cui sia le lettere furono minori né le forme di quelle simili alle nostre sia anche il valore diverso, come presso i Greci la lettera o, che talvolta lunga o breve, come presso di noi, talora fu posta al posto della sillaba che esprime col suo nome XII come dagli antichi Latini aggiunta la d finale a molte parole, il che risulta chiaro anche dalla colonna rostrata, che è posta nel foro Duilio, anche talvolta dalla g, come sull'altare del Sole, che è venerato vicino al tempio di Quirino, "vesperug", che intendiamo "vesperuginem" XIII Anche sul cambiamento delle lettere, di cui ho detto sopra, non è necessario ripetere nulla qui: infatti forse come scrivevano, parlavano anche XIV Per lungo tempo non fu di comunissimo uso il raddoppiare della semivocale e al contrario fino ad Accio ed oltre, come ho detto, scrissero le sillabe lunghe con doppie vocali |
Maybe you might be interested
Quintiliano, Institutio oratoria: 10; 01, 93-95
Latino: dall'autore Quintiliano, opera Institutio oratoria parte 10; 01, 93-95
| XV Diutius duravit ut e et i iungendis eadem ratione qua Graeci ei uterentur: ea casibus numerisque discreta est, ut Lucilius praecipit:"iam" "puerei venere": e postremum facito atque i, "ut pueri plures fiant" ac deinceps idem: "mendaci furique addes e, cum dare furi iusseris " XVI Quod quidem cum supervacuum est quia i tam longae quam brevis naturam habet, tum incommodum aliquando; nam in iis quae proximam ab ultima litteram e habebunt et i longa terminabuntur, illam rationem sequentes utemur e gemina, qualia sunt haec "aurei" "argentei" et his similia XVII idque iis praecipue qui ad lectionem instituentur etiam impedimento erit, sicut in Graecis accidit adiectione i litterae, quam non solum dativis casibus in parte ultima adscribunt, sed quibusdam etiam interponunt, ut in LEISTEI, quia etymologia ex divisione in tris syllabas facta desideret eam litteram |
XV Durò più a lungo come nel dover unire la e e la i nello stesso modo in cui i Greci usavano ei: essa è distinta in casi e numeri, come suggerisce Lucilio: "iam" "puerei venere": metterai la e alla fine e la i, "ut pueri plures fiant" e ancora lo stesso: "aggiungi a mendaci e a furi una e, quando avrai inteso furi al dativo" XVI Il che certo è comunque inutile poiché la i ha natura tanto di lunga che di breve, anche dannosa talvolta; infatti in quelle che avranno la e vicina all'ultima lettera e saranno concluse con la i lunga, seguendo quella regola useremo una doppia e, quali sono queste "aurei" "argentei" e simili a queste XVII e ciò sarà anche d'ostacolo soprattutto a quelli che saranno avviati alla lettura, come avviene fra i Greci con l'aggiunta della lettera i, che non solo sottoscrivono ai casi dativi nell'ultima parte, ma interpongono anche ad alcune parole, come in LEISTEI, perché l'etimologia ricavata dalla divisione in tre sillabe richiede questa lettera |
| XVIII Ae syllabam, cuius secundam nunc e litteram ponimus, varie per a et i efferebant, quidam semper ut Graeci, quidam singulariter tantum, cum in dativum vel genetivum casum incidissent, unde "pictai vestis" et "aquai" Vergilius amantissimus vetustatis carminibus inservit XIX In isdem plurali numero e utebantur: "hi Sullae, Galbae"; Est in hac quoque parte Lucili praeceptum, quod quia pluribus explicatur versibus, si quis parum credet apud ipsum in nono requirat XX Quid quod Ciceronis temporibus paulumque infra, fere quotiens s littera media vocalium longarum vel subiecta longis esset, geminabatur, ut "caussae" "cassus" "divissiones" Quo modo et ipsum et Vergilium quoque scripsisse manus eorum docent |
XVIII Pronunciavano la sillaba ae, di cui ora mettiamo la e seconda lettera, variamente tra la a e la i, alcuni sempre come i Greci, alcuni solo al singolare, essendosi imbattuti nel caso dativo o genitivo, da dove Virgilio molto amante dell'antichità conservò nei carmi "pictai vestis" e "aquai" XIX Nelle stesse nel numero plurale usavano la e: "questi Sullae, Galbae"; c'è anche in questa parte una norma di Lucilio, che poiché è spiegata con molti versi, se qualcuno si fida poco troverà presso lo stesso nel nono libro XX E cosa il fatto che ai tempi di Cicerone e poco dopo, quasi ogni volta che la lettera s era al centro di vocali lunghe o vicina alle lunghe, era raddoppiata, come "caussae" "cassus""divissiones" Le loro opere dimostrano che anche lui stesso e Virgilio avevano scritto in questo modo |
Maybe you might be interested
Quintiliano, Institutio oratoria: Liber 1, 10, 1-16
Latino: dall'autore Quintiliano, opera Institutio oratoria parte Liber 1, 10, 1-16
| XXI Atqui paulum superiores etiam illud quod nos gemina dicimus "iussi" una dixerunt; Iam "optimus" "maximus" ut mediam i litteram, quae veteribus u fuerat, acciperent primum Caesaris inscriptione traditur factum XXII "Here" nunc e littera terminamus: at veterum comicorum adhuc libris invenio "heri ad me venit": quod idem in epistulis Augusti, quas sua manu scripsit aut emendavit, deprenditur; Quid XXIII non Cato Censorius "dicam" et "faciam" "dicae" et "faciae" scripsit, eundemque in ceteris quae similiter cadunt modum tenuit Quod et ex veteribus eius libris manifestum est et a Messala in libro de s littera positum XXIV "Sibe" et "quase" scriptum in multorum libris est, sed an hoc voluerint auctores nescio: T Livium ita his usum ex Pediano comperi, qui et ipse eum sequebatur Haec nos i littera finimus |
XXI E anche quelli poco anteriori pronunciarono con una sola quello che noi pronunciamo "iussi" doppio; ormai "optimus" "maximus" cosicché accettassero centrale la lettera i, che per gli antichi era stata la u, si tramanda fatto per la prima volta con un'iscrizione di Cesare XXII Ora concludiamo "here" con la lettera e: ma nei testi degli antichi comici trovo ancora "heri venne da me": il che si ritrova uguale nelle lettere di Augusto, che scrisse o corresse di sua mano; E che XXIII Catone il Censore scrisse "dicae" e "faciae" non "dicam" e "faciam", e non mantenne la stessa forma nelle altre che terminano ugualmente Il che è evidente sia dai suoi vecchi libri sia rilevato da Messala nel libro sulla lettera s XXIV Nei libri di molti è scritto "sibe" e quase", ma non so se gli autori l'abbiano voluto: che T Livio usò queste forme l'appresi da Pediano, lui stesso lo imitava Noi concludiamo queste forme con la lettera i |
| XXV Quid dicam "vortices" et "vorsus" ceteraque ad eundem modum, quae primus Scipio Africanus in e litteram secundam vertisse dicitur XXVI Nostri praeceptores "servum" "cervum"que u et o litteris scripserunt, quia subiecta sibi vocalis in unum sonum coalescere et confundi nequiret; nunc u gemina scribuntur ea ratione quam reddidi: neutro sane modo vox quam sentimus efficitur, nec inutiliter Claudius Aeolicam illam ad hos usus litteram adiecerat XXVII Illud nunc melius, quod "cui" tribus quas praeposui litteris enotamus, in quo pueris nobis ad pinguem sane sonum qu et oi utebantur, tantum ut ab illo "qui" distingueretur XXVIII Quid quae scribuntur aliter quam enuntiantur Nam et "Gaius" C littera significatur, quae inversa mulierem declarat, quia tam Gaias esse vocitatas quam Gaios etiam ex nuptialibus sacris apparet |
XXV Come dirò "vortices" e "vorsus" e le altre secondo lo stesso tipo, che per primo Scipione Africano è detto aver cambiato in e a seconda lettera XXVI I nostri maestri scrissero "servum" e "cervum" con le lettere u e o, perché la vocale aggiunta a se stessa non poteva unirsi ed essere fusa in un suono; ora sono scritte con la doppia u per quel motivo che ho spiegato: certo né in modo né nell'altro è reso il suono che sentiamo, né Claudio aveva aggiunto invano quella lettera eolica per questi usi XXVII Ora migliore quello, che annotiamo con tre lettere che ho preposto a "cui", nel quale per noi fanciulli usavano qu e oi per un suono certo intenso, cosicché "qui" si distinguesse da quello XXVIII E cosa quelle che sono scritte diversamente da come sono pronunciate Infatti "Gaio" è espresso anche con la lettera C, che rivoltata indica il femminile, perché anche dai riti nuziali appare che erano stati usati tanto Gaia che Gaio |
Maybe you might be interested
Quintiliano, Institutio oratoria: Liber 1, 9
Latino: dall'autore Quintiliano, opera Institutio oratoria parte Liber 1, 9
| XXIX nec "Gnaeus" eam litteram in praenominis nota accipit qua sonat, et "columnam" et "consules" exempta n littera legimus, et "Subura", cum tribus litteris notatur, C tertiam ostendit Multa sunt generis huius, sed haec quoque vereor ne modum tam parvae quaestionis excesserint XXX Iudicium autem suum grammaticus interponat his omnibus: nam hoc valere plurimum debet Ego, nisi quod consuetudo optinuerit, sic scribendum quidque iudico quomodo sonat XXXI Hic enim est usus litterarum, ut custodiant voces et velut depositum reddant legentibus Itaque id exprimere debent quod dicturi sumus XXXII Hae fere sunt emendate loquendi scribendique partes: duas reliquas significanter ornateque dicendi non equidem grammaticis aufero, sed, cum mihi officia rhetoris supersint, maiori operi reservo |
XXIX né "Gneo" accetta questa lettera nell'abbreviazione del prenome con cui risuona, e tolta la lettera n leggiamo "columnam" e "consules", e "Subura" quando è abbreviata con tre lettere, mostra terza la C Molti sono di tal genere, ma temo che anche queste abbiano superato il limite di una tanto piccola questione XXX Un grammatico poi interponga a tutte queste cose il suo parere: infatti questo deve valere maggiormente Io, tranne se sarà prevalsa la consuetudine, penso che qualunque cosa si debba scrivere come risuona XXXI Infatti questo è l'uso delle lettere, affinché mantengano i suoni e lo rendano come conservato a quelli che leggono Perciò devono esprimere ciò che stiamo per dire XXXII Queste sono all'incirca le parti del parlare e dello scrivere esattamente: non toglierò certo ai grammatici le restanti due del parlare espressivamente ed elegantemente, ma, essendomi rimasti i compiti del retore, li riservo per un'opera maggiore |