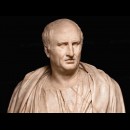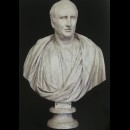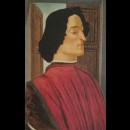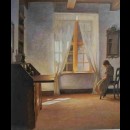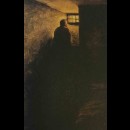| Nonne ipsa varietas, quae est propria fortunae, fortunam esse causam, non naturam esse docet Deinde, si tua ista conclusio, Cratippe, vera est (tecum enim mihi res est), nonne intellegis eadem uti posse et haruspices et fulguratores et interpretes ostentorum et augures et sortilegos et Chaldaeos Quorum generum nullum est, ex quo non aliquid, sicut praedictum sit, evaserit Ergo aut ea quoque genera divinandi sunt quae tu rectissume improbas, aut, si ea non sunt, non intellego cur haec duo sint quae relinquis Qua ergo ratione haec inducis, eadem illa possunt esse quae tollis |
Proprio questa incostanza di risultati, che è caratteristica del caso, non dovrà dimostrarci che dal caso, noti da una legge di natura, essi dipendono Inoltre, se codesta tua argomentazione è vera, caro Cratippo (dal momento che è con te che sto attualmente discutendo), non ti accorgi che di essa possono servirsi egualmente gli arùspici, gli interpreti dei fulmini e dei prodìgi, gli àuguri, gli estrattori di sorti, i caldei Di tutte queste forme di divinazione non ce n'è nemmeno una in base a cui, una volta su tante, l'evento non sia stato conforme alla predizione Dunque o anche queste forme di divinazione, che tu giustissimamente ripudii, sono valide, o, se non lo sono, non capisco perché lo siano quelle due sole che tu ammetti Grazie allo stesso ragionamento con cui tu dài il benestare a quelle, possono avere il diritto di esistere anche quelle che neghi |
| Quid vero habet auctoritatis furor iste, quem divinum vocatis, ut, quae sapiens non videat, ea videat insanus, et is, qui humanos sensus amiserit, divinos adsecutus sit Sibyllae versus observamus, quos illa furens fudisse dicitur Quorum interpres nuper falsa quadam hominum fama dicturus in senatu putabatur eum, quem re vera regem habebamus, appellandum quoque esse regem, si salvi esse vellemus Hoc si est in libris, in quem hominem et in quod tempus est Callide enim, qui illa composuit, perfecit ut, quodcumque accidisset, praedictum videretur, hominum et temporum definitione sublata Adhibuit etiam latebram obscuritatis, ut iidem versus alias in aliam rem posse accommodari viderentur |
Quale autorità, d'altronde, può avere codesto stato di folle eccitazione che chiamate divino, in virtù del quale ciò che il savio non vede, lo vedrebbe il pazzo, e colui che ha perduto le facoltà sensoriali umane avrebbe acquisito quelle divine Noi crediamo ai carmi della Sibilla, che essa, si dice, pronunciò in stato di esaltazione Si credeva poco tempo fa, per una dicerìa infondata diffusasi tra la gente, che un interprete di tali carmi si apprestasse a dire in senato che colui che di fatto era già nostro re avrebbe dovuto anche ricevere il titolo regale, se volevamo esser salvi Se questo è scritto nei libri sibillini, a quale uomo e a quale tempo si riferisce Colui che aveva scritto quei versi aveva agito furbescamente: omettendo ogni precisazione di persona e di tempo, aveva fatto in modo che, qualunque cosa accadesse, sembrasse l'avveramento di una profezia Aveva aggiunto anche l'oscurità dell'espressione, perché gli stessi versi potessero adattarsi ora ad una cosa, ora a un'altra in diverse circostanze |
| Non esse autem illud carmen furentis cum ipsum poëma declarat (est enim magis artis et diligentiae quam incitationis et motus), tum vero ea, quae a(krostixi j dicitur, cum deinceps ex primis versus litteris aliquid conectitur, ut in quibusdam Ennianis: Q ENNIUS FECIT Id certe magis est attenti animi quam furentis Atque in Sibyllinis ex primo versu cuiusque sententiae primis litteris illius sententiae carmen omne praetexitur Hoc scriptoris est, non furentis, adhibentis diligentiam, non insani |
Che quel carme, poi, non sia il parto di uno spirito invasato, lo rivela sia la fattura dei versi stessi (che sono un prodotto di arte raffinata e accurata, non di eccitazione e di impeto), sia quel tipo di composizione che si suol chiamare acrostico, nella quale, leggendo di séguito le prime lettere di ciascun verso, si mette insieme un'espressione di senso compiuto, come in alcune poesie di Ennio: QUINTO ENNIO FECE Un simile artifizio è certamente caratteristico di una mente attenta, non furente E nei libri sibillini, l'intero carme risulta dal primo verso di ciascuna frase, mettendo di séguito le prime lettere di quella frase Questo è il modo di procedere di uno scrittore, non di un invasato; di uno che lavora con minuta accuratezza, non di un folle |
Maybe you might be interested
Cicerone, De divinationes: Libro 01 - Parte 03
Latino: dall'autore Cicerone, opera De divinationes parte Libro 01 - Parte 03
| Quam ob rem Sibyllam quidem sepositam et conditam habeamus, ut, id quod proditum est a maioribus, iniussu senatus ne legantur quidem libri valeantque ad deponendas potius quam ad suscipiendas religiones; cum antistitibus agamus, ut quidvis potius ex illis libris quam regem proferant, quem Romae posthac nec di nec homines esse patientur At multi saepe vera vaticinati, ut Cassandra: iamque mari magno eademque paulo post: 'eheu videte Num igitur me cogis etiam fabulis credere Quae delectationis habeant quantum voles, verbis sententiis numeris cantibus adiuventur; auctoritatem quidem nullam debemus nec fidem commenticiis rebus adiungere |
Perciò teniamo ben appartata e segregata la Sibilla, in modo che, come ci è stato tramandato dai nostri antenati, senza un ordine esplicito del senato non vengano nemmeno letti i suoi libri, e servano a far abbandonare i timori superstiziosi anziché a farli sorgere; coi sacerdoti addetti all'interpretazione di quei carmi facciamo un patto: che da quei libri tirino fuori qualsiasi cosa tranne un re, poiché d'ora in poi né gli dèi né gli uomini permetteranno che un re vi sia a Roma Ma obietterai, molti hanno spesso vaticinato il vero, come Cassandra: 'E già nel vasto mare', e poco dopo: 'Ahimè, guardate ' Mi costringi dunque anche a credere alle invenzioni delle tragedie Esse arrecheranno diletto artistico quanto vorrai, si faranno ammirare per le parole, per le frasi, per i ritmi, per la musica; ma nessuna autorità né credibilità dobbiamo attribuire a cose inventate |
| Eodemque modo nec ego Publicio nescio cui nec Marciis vatibus nec Apollinis opertis credendum existimo; quorum partim ficta aperte, partim effutita temere numquam ne mediocri quidem cuiquam, non modo prudenti probata sunt Quid' inquies, remex ille de classe Coponi nonne ea praedixit quae facta sunt Ille vero, et ea quidem quae omnes eo tempore ne acciderent timebamus Castra enim in Thessalia castris conlata audiebamus, videbaturque nobis exercitus Caesaris et audaciae plus habere, quippe qui patriae bellum intulisset, et roboris propter vetustatem; casum autem proeli nemo nostrum erat quin timeret, sed, ita ut constantibus hominibus par erat, non aperte |
E allo stesso modo io sostengo che non si debba credere né a quel tale ignoto Publilio né ai vati Marcii né agli enigmi di Apollo: alcune di queste profezie sono chiaramente delle invenzioni, altre sono state proferite senza discernimento; nessuno, neanche di mediocre levatura, vi ha creduto, meno ancora le persone dotate d'ingegno Ma come, dirai, quel rematore della flotta di Coponio non predisse appunto ciò che poi avvenne Certo, Predisse appunto ciò che tutti, allora, temevano che accadesse Sentivamo dire che in Tessaglia gli accampamenti dei due eserciti erano ormai l'uno di fronte all'altro; ritenevamo che l'esercito di Cesare avesse più sfrenato ardire, poiché aveva preso le armi contro la patria, e più forza per la lunga esperienza nel guerreggiare; l'esito della battaglia, nessuno di noi c'era che non lo temesse; ma, come si conveniva a persone dotate di fermezza d'animo, non davamo segni di timore |
Maybe you might be interested
Cicerone, De divinationes: Libro 02 - Parte 01
Latino: dall'autore Cicerone, opera De divinationes parte Libro 02 - Parte 01
| Ille autem Graecus, quid mirum si magnitudine timoris, ut plerumque fit, a constantia atque a mente atque a se ipse discessit Qua perturbatione animi, quae, sanus cum esset, timebat ne evenirent, ea demens eventura esse dicebat Utrum tandem, per deos atque homines, magis veri simile est vesanum remigem an aliquem nostrum, qui ibi tum eramus, me, Catonem, Varronem, Coponium ipsum, consilia deorum immortalium perspicere potuisse Sed iam ad te venio, o sancte Apollo, qui umbilicum certum terrarum obsides,unde superstitiosa primum saeva evasit vox fera |
Quel greco invece, che c'è di strano se per un eccesso di paura, come tante volte accade, perse il controllo e il senno e uscì fuori di sé In séguito a questa perturbazione d'animo, quelle cose che, finché era sano di mente, temeva, andava dicendo che sarebbero avvenute quand'ebbe perso la ragione Ma, per tutti gli dèi e gli uomini, è più verosimile che la volontà degli dèi immortali sia stata prevista da un rematore impazzito o da qualcuno di noi che allora eravamo lì, da me, da Catone, da Varrone, da Coponio stesso Ma eccomi giunto a te, O venerando Apollo, che occupi il vero ombelico del mondo, donde primamente uscì la profetica voce orrida, terribile |
| Tuis enim oraclis Chrysippus totum volumen implevit partim falsis, ut ego opinor, partim casu veris, ut fit in omni oratione saepissime, partim flexiloquis et obscuris, ut interpres egeat interprete et sors ipsa ad sortes reverenda sit, partim ambiguis et quae ad dialecticum deferenda sint Nam cum illa sors edita est opulentissumo regi Asiae: Croesus Halyn penetrans magnam pervertet opum vimhostium vim se perversurum putavit, pervertit autem suam: utrum igitur eorum accidisset, verum oraclum fuisset Cur autem hoc credam umquam editum Croeso Aut Herodotum cur veraciorem ducam Ennio Num minus ille potuit de Croeso quam de Pyrrho fingere Ennius |
Dei tuoi oracoli Crisippo ha riempito un intero libro: alcuni falsi, a mio parere, altri avveratisi per caso, come spessissimo avviene in qualsiasi discorso, altri tortuosi e oscuri (cosicché l'interprete ha, a sua volta, bisogno di un interprete, e la sorte stessa va indagata ricorrendo alle sorti), altri ancora a doppio senso e bisognosi dell'indagine di un dialettico Quando fu dato quel famoso responso al più ricco dei re d'Asia: Creso attraversando l'Halys manderà in rovina una grande potenza egli credette che avrebbe mandato in rovina la potenza dei nemici, mandò invece in rovina la propria: si fosse verificata l'una o l'altra delle due possibilità, l'oracolo sarebbe egualmente apparso vero Perché, d'altra parte, dovrei credere che Creso abbia mai ricevuto realmente questo responso O perché dovrei considerare Erodoto più verace di Ennio Erodoto non poté forse essere stato meno fantasioso a proposito di Creso di quanto lo fu Ennio a proposito di Pirro |
Maybe you might be interested
Cicerone, De divinationes: Libro 02 - Parte 03
Latino: dall'autore Cicerone, opera De divinationes parte Libro 02 - Parte 03
| Quis enim est, qui credat Apollinis ex oraclo Pyrrho esse responsum: aiio te, Aeacida, Romanos vincere posse Primum latine Apollo numquam locutus est; deinde ista sors inaudita Graecis est; praeterea Pyrrhi temporibus iam Apollo versus facere desierat; postremo, quamquam semper fuit, ut apud Ennium est, stolidum genus Aeacidarum- bellipotentes sunt magis quam sapientipotentes -,tamen hanc amphiboliam versus intellegere potuisset, vincere te Romanos nihilo magis in se quam in Romanos valere; nam illa amphibolia, quae Croesum decepit, vel Chrysippum potuisset fallere, haec vero ne Epicurum quidam Sed, quod caput est, cur isto modo iam oracla Delphis non eduntur non modo nostra aetate, sed iam diu [tantum modo], iam ut nihil possit esse contemptius |
Chi è disposto a credere che Pirro ricevé dall'oracolo di Apollo il responso: Dico te, Eacide, poter vincere i romani Innanzi tutto, Apollo non parlò mai in latino; poi, di questo responso gli autori greci non sanno nulla; inoltre, al tempo di Pirro Apollo aveva già smesso di far versi; e infine, sebbene sia sempre stata, come Ennio dice, Stolta la stirpe degli Eacidi - son potenti in guerra più che nella saggezza -, tuttavia Pirro avrebbe potuto capire che il doppio senso contenuto in quel verso, te vincere i romani, non era per nulla più favorevole a lui che ai romani; ché quel doppio senso che ingannò Creso avrebbe potuto ingannare anche un Crisippo, ma questo, relativo a Pirro, non avrebbe ingannato neanche Epicuro Ma, e questa è la cosa principale, come mai a Delfi non vengono più pronunciati oracoli di questo genere, e non solo ai nostri tempi, ma già da molto, di modo che niente può essere ormai oggetto di maggior disprezzo |
| Hoc loco cum urguentur evanuisse aiunt vetustate vim loci eius, unde anhelitus ille terrae fieret, quo Pythia mente incitata oracla ederet De vino aut salsamento putes loqui, quae evanescunt vetustate; de vi loci agitur, neque solum naturali, sed etiam divina; quae quo tandem modo evanuit Vetustate, inquies Quae vetustas est, quae vim divinam conficere possit Quid tam divinum autem quam adflatus e terra mentem ita movens ut eam providam rerum futurarum efficiat, ut ea non modo cernat multo ante, sed etiam numero versuque pronuntiet Quando ista vis autem evanuit An postquam homines minus creduli esse coeperunt |
Quando vengono messi alle strette su questo punto, rispondono che per l'antichità è svanita la forza di quel luogo, la quale produceva quelle esalazioni che esaltavano l'anima della Pizia e le facevano proferire gli oracoli Diresti che costoro parlino del vino o della salamoia, che perdono sapore col tempo; si tratta della forza sprigionantesi da un luogo, e di una forza non meramente naturale, ma addirittura divina; come mai, dunque, essa è potuta svanire Per il lungo tempo trascorso, tu dirai Ma quale durata di tempo può essere in grado di esaurire una forza divina E, d'altra parte, che cosa può esserci di tanto divino quanto un afflato prorompente dalla terra, capace di eccitare la mente umana in modo da renderla presàga del futuro, in modo che la mente non solo lo veda con grande anticipo, ma anche lo reciti in versi ben ritmati E quando codesta forza è svanita Forse quando gli uomini incominciarono a essere meno crèduli |
Maybe you might be interested
Cicerone, De divinationes: Libro 01 - Parte 02
Latino: dall'autore Cicerone, opera De divinationes parte Libro 01 - Parte 02
| Demosthenes quidem, qui abhinc annos prope trecentos fuit, iam tum filippi zein Pythiam dicebat, id est quasi cum Philippo facere Hoc autem eo spectabat, ut eam a Philippo corruptam diceret; quod licet existumare in aliis quoque oraclis Delphicis aliquid non sinceri fuisse Sed nescio quo modo isti philosophi superstitiosi et paene fanatici quidvis malle videntur quam se non ineptos Evanuisse mavultis et extinctum esse id quod, si umquam fuisset, certe aeternum esset, quam ea, quae non sunt credenda, non credere Similis est error in somniis; quorum quidem defensio repetita quam longe est |
Demostene, che visse circa trecento anni fa, già allora diceva che la Pizia filippeggiava, cioè, per così dire, prendeva le parti di Filippo Questa frase mirava a far intendere che la Pizia era stata corrotta da Filippo;è dunque lecito credere che anche in altri responsi dell'oracolo di Delfi vi sia stato qualcosa di non veritiero Ma, non so come, sembra che questi filosofi superstiziosi e, starei per dire, fanatici vogliano a tutti i costi far la figura degli sciocchi Vi ostinate a sostenere che è svanita ed estinta una forza che, se mai vi fosse stata, sarebbe senza dubbio eterna, piuttosto che rinunciare a credere cose incredibili Un errore analogo si commette a proposito dei sogni; da quanto lontano prendono le mosse nel difenderli |