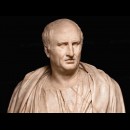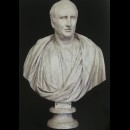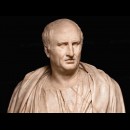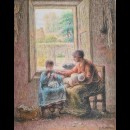| Nam nisi hoc optineatur, id solum bonum esse, quod honestum sit, nullo modo probari possit beatam vitam virtute effici Quod si ita sit, cur opera philosophiae sit danda nescio Si enim sapiens aliquis miser esse possit, ne ego istam gloriosam memorabilemque virtutem non magno aestimandam putem [4, 12] Quae adhuc, Cato, a te dicta sunt, eadem, inquam, dicere posses, si sequerere Pyrrhonem aut Aristonem Nec enim ignoras his istud honestum non summum modo, sed etiam, ut tu vis, solum bonum videri Quod si ita est, sequitur id ipsum, quod te velle video, omnes semper beatos esse sapientes Hosne igitur laudas et hanc eorum, inquam, sententiam sequi nos censes oportere Minime vero istorum quidem, inquit |
Se infatti non si raggiunge la conclusione che è bene solo ciò che è onesto, risulta assolutamente impossibile dimostrare che la virtù produce la felicità nella vita Se è così, non so perché valga la pena di dedicarsi alla filosofia Giacché, se un sapiente potesse essere infelice, non ritenei davvero degna di grande considerazione codesta virtù piena di gloria e degna di essere celebrata [4, 12] Ciò che hai detto finora, o Catone, lavresti potuto dire lo stesso se seguissi Pirrone o Aristone Tu sai bene infatti che anche loro son davviso che codesta onestà non solo è il sommo bene, ma anche lunico, proprio come vuoi tu Se è così, ne consegue proprio quello che, a quanto vedo, tu sostieni: tutti i sapienti sono sempre felici Li approvi dunque e reputi che dobbiamo seguire questa loro opinione Lopinione di costoro proprio no |
| Cum enim virtutis hoc proprium sit, earum rerum, quae secundum naturam sint, habere delectum, qui omnia sic exaequaverunt, ut in utramque partem ita paria redderent, uti nulla selectione uterentur, hi virtutem ipsam sustulerunt [13] Istud quidem, inquam, optime dicis, sed quaero nonne tibi faciendum idem sit nihil dicenti bonum, quod non rectum honestumque sit, reliquarum rerum discrimen omne tollenti Si quidem, inquit, tollerem, sed relinquo [14] Quonam modo Inquam Si una virtus, unum istud, quod honestum appellas, rectum, laudabile, decorum erit enim notius quale sit pluribus notatum vocabulis idem declarantibus, id ergo, inquam, si solum est bonum, quid habebis praeterea, quod sequare Aut, si nihil malum, nisi quod turpe, inhonestum, indecorum, pravum, flagitiosum, foedumut hoc quoque pluribus nominibus insigne faciamus, quid praeterea dices esse fugiendum |
La caratteristica della virtù è di avere una scelta di ciò che è secondo natura: chi ha livellato ogni cosa in modo da rendere tutto uguale rispettoagli opposti valori, escludendo cosi ogni possibilità di selezione, ha soppresso la stessa virtù [13] Hai perfettamente ragione, ma ti chiedo se non devi far lo stesso dicendo che non è bene ciò che non è retto ed onesto, in quanto elimini ogni distinzione per tutto il rimanente Se la eliminassi si, ma io la lascio [14] E in che modo Dico Se la sola virtù, se solo ciò che chiami onesto, retto, lodevole e decoroso (indicandolo con più sinonimi, si renderà più nota la sua natura), se,stavo licendo, solo questo è bene, che avrai da seguire allinfuori di esso oppure, se non è male se non ciò che è vergognoso, disonesto, indecoroso, perverso, obbrobrioso, sconcio (per rendere chiaro anche questo concetto con più denominazioni), che dirai che bisogna evitare allinfuori di questo |
| Non ignoranti tibi, inquit, quid sim dicturus, sed aliquid, ut ego suspicor, ex mea brevi responsione arripere cupienti non respondebo ad singula, explicabo potius, quoniam otiosi sumus, nisi alienum putas, totam Zenonis Stoicorumque sententiam Minime id quidem, inquam, alienum, multumque ad ea, quae quaerimus, explicatio tua ista profecerit [15] Experiamur igitur, inquit, etsi habet haec Stoicorum ratio difficilius quiddam et obscurius Nam cum in Graeco sermone haec ipsa quondam rerum nomina novarum * * non videbantur, quae nunc consuetudo diuturna trivit; quid censes in Latino fore Facillimum id quidem est, inquam Si enim Zenoni licuit, cum rem aliquam invenisset inusitatam, inauditum quoque ei rei nomen inponere, cur non liceat Catoni |
Tu non ignori che cosa sto per dirti, ma desideri cogliere a volo, ne ho il sospetto, qualche particolare da una mia risposta breve: quindi non risponderò alle singole obiezioni, ma spiegherò piuttosto, visto che abbiamo tempo libero, tutta quanta la teoria di Zenone e degli Stoici, a meno che tu non lo ritenga inopportuno No, non è affatto inopportuno; anzi codesta tua esposizione sarà molto vantaggiosa per loggetto della nostra indagine [15] Proviamo dunque, anche se questa dottrina stoica ha certi punti un po difficili ed oscuri Infatti quando in greco erano una novità queste denominazioni introdotte un tempo per concetti nuovi, sembravano termini inammissibili quelli che ora una lunga consuetudine rese familiari; che pensi che avverrà in latino molto facile Se a Zenone, quando scopriva un concetto inusitato, fu lecito dargli un nome pur esso mai prima udito, perché non dovrebbe esser lecito a Catone |
Maybe you might be interested
Cicerone, De Finibus: Libro 02; 01-05
Latino: dall'autore Cicerone, opera De Finibus parte Libro 02; 01-05
| Nec tamen exprimi verbum e verbo necesse erit, ut interpretes indiserti solent, cum sit verbum, quod idem declaret, magis usitatum Equidem soleo etiam quod uno Graeci, si aliter non possum, idem pluribus verbis exponere Et tamen puto concedi nobis oportere ut Graeco verbo utamur, si quando minus occurret Latinum, ne hoc ephippiis et acratophoris potius quam proegmenis et apoproegmenis concedatur; quamquam haec quidem praeposita recte et reiecta dicere licebit [16] Bene facis, inquit, quod me adiuvas, et istis quidem, quae modo dixisti, utar potius Latinis, in ceteris subvenies, si me haerentem videbis Sedulo, inquam, faciam Sed 'fortuna fortis'; quare conare, quaeso Quid enim possumus hoc agere divinius |
Daltra parte non sarà necessaria una traduzione letterale, come fanno di solito gli interpreti poveri di parole, quando esista una parola più usata che ha il medesimo significato Per conto mio son solito, se non posso fare altrimenti, anche rendere con più parole il medesimo concetto che in greco ne richiede una sola Tuttavia ritengo che bisogna concederci di usare il termine grecose qualche volta non ricorre in latino, ad evitare che tale concessione sia fatta per efippie acratòfori piuttosto che per proègmeni e apoproègmeni ; per quanto, per questi ultimi sarà lecito dire giustamente cose preferite e cose rifiutate [16] Fai bene ad aiutarmi, e per questi concetti che ora hai detto userò di preferenza i termini latini; per gli altri mi verrai in aiuto, se mi vedrai in difficoltà Lo farò con impegno Ma la fortuna aiuta i forti ; perciò tenta, ti prego Quale mai attività possiamo svolgere più divina di questa |
| [5]Placet his, inquit, quorum ratio mihi probatur, simulatque natum sit animalhinc enim est ordiendum, ipsum sibi conciliari et commendari ad se conservandum et ad suum statum eaque, quae conservantia sint eius status, diligenda, alienari autem ab interitu iisque rebus, quae interitum videantur adferre Id ita esse sic probant, quod ante, quam voluptas aut dolor attigerit, salutaria appetant parvi aspernenturque contraria, quod non fieret, nisi statum suum diligerent, interitum timerent Fieri autem non posset ut appeterent aliquid, nisi sensum haberent sui eoque se diligerent Ex quo intellegi debet principium ductum esse a se diligendo [17] in principiis autem naturalibus [diligendi sui] plerique Stoici non putant voluptatem esse ponendam |
[5] Questi di cui io seguo la dottrina sostengono che lessere animato, appena nato (di qui bisogna prender le mosse), ha simpatia per se stesso e si assume il còmpito della propria conservazione e della predilezione per il proprio stato e per ciò che è atto a conservare tale stato; prova invece ripulsione per lannientamento e per ciò che sembra recare allannientamento Dimostrano la verità di questa asserzione nel seguente modo, che i piccoli, prima che il piacere o il dolore li abbia sfiorati, desiderano il benessere e rifuggono dal suo contrario: ciò non avverrebbe, se non amassero il loro stato e non temessero lannientamento Daltra parte non sarebbe possibile che desiderassero qualche cosa, se non avessero coscienza di sé e quindi amore per se stessi Da ciò si deve dedurre che il principio fondamentale è derivato dallamore per se stessi [17] Però la maggior parte degli Stoici non ritengono che si debba pone il piacere fra i principi naturali |
Maybe you might be interested
Cicerone, De Finibus: Libro 01; 04-06
Latino: dall'autore Cicerone, opera De Finibus parte Libro 01; 04-06
| Quibus ego vehementer adsentior, ne, si voluptatem natura posuisse in iis rebus videatur, quae primae appetuntur, multa turpia sequantur Satis esse autem argumenti videtur quam ob rem illa, quae prima sunt adscita natura, diligamus, quod est nemo, quin, cum utrumvis liceat, aptas malit et integras omnis partis corporis quam, eodem usu, inminutas aut detortas habere Rerum autem cognitiones, quas vel comprehensiones vel perceptiones vel, si haec verba aut minus placent aut minus intelleguntur, katalèpseis appellemus licet, eas igitur ipsas propter se adsciscendas arbitramur, quod habeant quiddam in se quasi complexum et continens veritatem Id autem in parvis intellegi potest, quos delectari videamus, etiamsi eorum nihil intersit, si quid ratione per se ipsi invenerint |
Ed io son pienamente daccordo con loro, ad evitare che, se risultasse che la natura ha posto il piacere fra quelli che sono i nostri primi desideri, ne derivino molte conseguenze vergognose Un argomento sufficiente a spiegare perché amiamo le prime esigenze della natura sembra questo: non cè nessuno che non preferisca, avendo facoltà di scelta, avere tutte le parti del corpo funzionanti e integre piuttosto che, pur facendone il medesimo uso, minorate o storpiate Quanto alle cognizioni delle cose, che possiamo chiamarecomprensioni o percezioni o, se questi termini sono meno graditi o meno intellegibili, in greco katcdépseis, riteniamo che si debbano accogliere per se stesse, in quanto hanno in sé qualcosa che per così dire abbraccia e contiene la verità E si può capire ciò nei piccoli, che, a quanto vediamo, provano diletto se riescono a far qualche scoperta da sé soli, mediante la ragione, anche se per loro non ha importanza |
| [18] Artis etiam ipsas propter se adsumendas putamus, cum quia sit in iis aliquid dignum adsumptione, tum quod constent ex cognitionibus et contineant quiddam in se ratione constitutum et via A falsa autem adsensione magis nos alienatos esse quam a ceteris rebus, quae sint contra naturam, arbitrantur Iam membrorum, id est partium corporis, alia videntur propter eorum usum a natura esse donata, ut manus, crura, pedes, ut ea, quae sunt intus in corpore, quorum utilitas quanta sit a medicis etiam disputatur, alia autem nullam ob utilitatem quasi ad quendam ornatum, ut cauda pavoni, plumae versicolores columbis, viris mammae atque barba [19] Haec dicuntur fortasse ieiunius; sunt enim quasi prima elementa naturae, quibus ubertas orationis adhiberi vix potest, nec equidem eam cogito consectari |
[18] Anche delle arti pensiamo che si debbano accettare per se stesse, sia perché si presenta in esse qualcosa che merita di essere accettato, sia perché risultano formate di cognizioni e contengono in sé qualcosa costituito di ragione e metodo Il falso assenso poi, secondo la teoria stoica, suscita in noi un senso di ripulsione più che ogni altra cosa contraria a natura Veniamo ora alle membra, cioè alle parti del corpo: alcune sembrano date dalla natura per il loro impiego, come per esempio le mani, le gambe, i piedi, per esempio quelle interne al corpo, il cui grado di utilità forma anche oggetto di discussione da parte dei medici; altre invece sembrano date per nessun utile impiego, quasi per ornamento, come per esempio la coda al pavone, le penne screziate ai piccioni, le mammelle e la barba agli uomini [19] Forse questa mia esposizione è troppo arida; si tratta invero, vorrei dire, dellabici della natura, per cui riesce difficile impiegare uno stile facondo, ed io non penso davvero a perseguirlo |
Maybe you might be interested
Cicerone, De Finibus: Libro 01; 07-10
Latino: dall'autore Cicerone, opera De Finibus parte Libro 01; 07-10
| Verum tamen cum de rebus grandioribus dicas, ipsae res verba rapiunt; ita fit cum gravior, tum etiam splendidior oratio Est, ut dicis, inquam Sed tamen omne, quod de re bona dilucide dicitur, mihi praeclare dici videtur Istius modi autem res dicere ornate velle puerile est, plane autem et perspicue expedire posse docti et intellegentis viri |
Però, quando si trattano argomenti più grandiosi, è largomento stesso che trascina le parole; e così il discorso diviene non solo più grave ma anche più smagliante proprio come dici Pur tutta a mio parere, ogni esposizione chiara di un buon argomento va benissimo Daltra parte sarebbe puerile voler usare uno stile ornato per orgomenti siffatti, mentre è proprio di una persona colta e intelligente riuscire a cavarsela con semplicità e chiarezza |