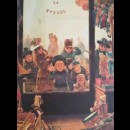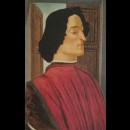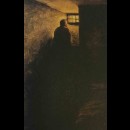| [1] Est etiam sua loquentibus observatio, sua scribentibus | [1] C'è anche una propria regola per quelli che parlano, una propria per quelli che scrivono |
| Sermo constat ratione vetustate auctoritate consuetudine | Il linguaggio consiste nel metodo nell'antichità nell'autorità nella consuetudine |
| Rationem praestat praecipue analogia, nonnumquam etymologia | Garantisce il metodo soprattutto l'analogia, talvolta l'etimologia |
Maybe you might be interested
Quintiliano, Institutio oratoria: 10; 01, 93-95
Latino: dall'autore Quintiliano, opera Institutio oratoria parte 10; 01, 93-95
| Vetera maiestas quaedam et, ut sic dixerim, religio commendat | Un certo antico prestigio e, per direi così, un sacro rispetto interviene |
| [2] Auctoritas ab oratoribus vel historicis peti solet (nam poetas metri necessitas excusat, nisi si quando nihil impediente in utroque modulatione pedum alterum malunt, qualia sunt "imo de stirpe recisum" et "aeriae quo congessere palumbes" et "silice in nuda" et similia): cum summorum in eloquentia virorum iudicium pro ratione, et vel error honestus est magnos duces sequentibus | [2] L'autorità suole essere conseguita dagli oratori o dagli storici (infatti la necessità del metro giustifica i poeti, a meno che talvolta pur con una modulazione che non impedisce nulla in entrambi preferiscono un altro verso, quali sono "imo de stirpe recisum" e "aeriate quo contessere palumbes" e "silice in nuda" e simili): poiché nell'eloquenza c'è il parere dei sommi personaggi come sistema, e anche l'errore è lecito a quelli che seguono i grandi modelli |
Maybe you might be interested
Quintiliano, Institutio oratoria: Liber 1, 4, 1-15
Latino: dall'autore Quintiliano, opera Institutio oratoria parte Liber 1, 4, 1-15
| [3] Consuetudo vero certissima loquendi magistra, utendumque plane sermone, ut nummo, cui publica forma est | [3] La consuetudine in realtà maestra sicurissima del parlare, bisogna certo usare nel linguaggio, come per la moneta, a cui spetta una forma comune |
| Omnia tamen haec exigunt acre iudicium, analogia praecipue: [4] quam proxime ex Graeco transferentes in Latinum proportionem vocaverunt | Ma tutte queste cose richiedono una difficile scelta, soprattutto l'analogia: [4]che trasferendo molto presto dal greco in latino chiamarono proporzione |
Maybe you might be interested
Quintiliano, Institutio oratoria: Liber 1, 10, 1-16
Latino: dall'autore Quintiliano, opera Institutio oratoria parte Liber 1, 10, 1-16
| Eius haec vis est, ut id quod dubium est ad aliquid simile de quo non quaeritur referat, et incerta certis probet | Questo è il suo valore, cosicché riporta ciò che è incerto a qualcosa di simile su cui non si discute, e dimostra le cose incerte con le certe |
| Quod efficitur duplici via: comparatione similium in extremis maxime syllabis, propter quod ea quae sunt e singulis negantur debere rationem, et deminutione | Il che si ottiene in duplice modo: con il confronto di somiglianze soprattutto nelle sillabe finali, per questo quelle che derivano dalle singole sono negate avere una regola, e con il diminuitivo |
Maybe you might be interested
Quintiliano, Institutio oratoria: Liber 1, 10, 17-33
Latino: dall'autore Quintiliano, opera Institutio oratoria parte Liber 1, 10, 17-33
| [5] Comparatio in nominibus aut genus deprendit aut declinationem: genus, ut, si quaeratur "funis" masculinum sit an femininum, simile illi sit "panis": declinationem, ut, si veniat in dubium "hac domu" dicendum sit an "hac domo", et "domuum" an "domorum", similia sint "domus" "anus" "manus" | [5] Nei nomi il confronto riguarda o il genere o la declinazione: il genere, cosicché, se si cerca se "funis" sia maschile o femminile, simile a quello sia "panis": la declinazione, cosicché, se viene in dubbio si debba dire "hac domu" o "hac domo", e "domuum" o "domorum", siano simili "domus" "anus" "manus" |