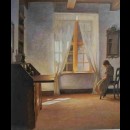| [VIII] Litterae eximiae consulum C Fabricii et Q Aemilii ad regem Pyrrum a Q Claudio scriptore historiarum in memoriam datae [1] Cum Pyrrus rex in terra Italia esset et unam atque alteram pugnas prospere pugnasset satisque agerent Romani et pleraque Italia ad regem descivisset, tum Ambraciensis quispiam Timochares, regis Pyrri amicus, ad C Fabricium consulem furtim venit ac praemium petivit et, si de praemio conveniret, promisit regem venenis necare idque facile esse factu dixit, quoniam filii sui pocula in convivio regi ministrarent [2] Eam rem Fabricius ad senatum scripsit [3] Senatus ad regem legatos misit mandavitque, ut de Timochare nihil proderent, sed monerent, uti rex circumspectius ageret atque a proximorum insidiis salutem tutaretur [4] Hoc ita, uti diximus, in Valeri Antiatis historia scriptum est |
[VIII] Belle lettere dei consoli C Fabrizio e Q Emilio al re Pirro tramandate alla memoria da Q Claudio scrittore di fatti storici [1] Essendo il re Pirro nella terra d'Italia e avendo combattuto felicemente l'una e l'altra battaglia e preoccupandosi abbastanza i Romani ed essendo passata la maggior parte d'Italia al re, allora un certo Timochares di Ambracia, amico del re Pirro, andò di nascosto dal console C Fabrizio e chiese una ricompensa e, se si accordava sul compenso, promise di avvelenare il re e disse essere ciò di facile esecuzione, perché nel banchetto del re erano somministrate le bevande di suo figlio [2] Fabrizio scrisse questa cosa al senato [3] Il senato mandò gli ambasciatori al re e ordinò, che non dicessero nulla su Timochares, ma consigliassero, affinché il agisse più attentamente e salvaguardasse la salute dalle insidie di quelli che erano vicini [4] Così, come abbiamo detto, fu scritto ciò nel racconto di Valerio Anziate |
| [5] Quadrigarius autem in libro tertio non Timocharem, sed Niciam adisse ad consulem scripsit neque legatos a senatu missos, sed a consulibus, et Pyrrum populo Romano laudes atque gratias scripsisse captivosque omnes, quos tum habuit, vestivisse et reddidisse [6] Consules tum fuerunt C Fabricius et Q Aemilius Litteras, quas ad regem Pyrrum super ea causa miserunt, [7] Claudius Quadrigarius scripsit fuisse hoc exemplo: [8] "Consules Romani salutem dicunt Pyrro regi Nos pro tuis iniuriis continuis animo tenus commoti inimiciter tecum bellare studemus Sed communis exempli et fidei ergo visum, ut te salvum velimus, ut esset, quem armis vincere possimus Ad nos venit Nicias familiaris tuus, qui sibi praemium a nobis peteret, si te clam interfecisset |
[5] Quadrigario poi nel terzo libro scrisse che non Timochares, ma Nicia era andato dal console e gli ambasciatori mandati non dal senato, ma dai consoli, e che Pirro aveva scritto elogi e ringraziamenti al popolo romano e che aveva rivestito e restituito tutti i prigionieri, che allora aveva avuto [6] Allora erano stati consoli C Fabrizio e Q Emilio Le lettere, che su tale circostanza mandarono al re Pirro, [7] Claudio Quadrigario scrisse essere state di tale genere: [8] "I consoli romani salutano il re Pirro Scossi fino all'animo per le tue continue offese riteniamo di combattere con te ostilmente Ma dunque affinchè fosse ragione di esempio e di onore comune, cosicché vogliamo salvo te, che possiamo vincere con le armi Da noi venne il tuo amico Nicia, che ci chiedeva una ricompensa per sé, se ti avesse ucciso di nascosto |
| Id nos negavimus velle, neve ob eam rem quicquam commodi exspectaret, et simul visum est, ut te certiorem faceremus, ne quid eiusmodi, si accidisset, nostro consilio civitates putarent factum, et quod nobis non placet pretio aut praemio aut dolis pugnare Tu, nisi caves, iacebis " [IX] Quis et cuiusmodi fuerit qui in proverbio fertur equus Seianus; et qualis color equorum sit qui "spadices" vocantur; deque istius vocabuli ratione [1] Gavius Bassus in commentariis suis, item Iulius Modestus in secundo quaestionum confusarum historiam de equo Seiano tradunt dignam memoria atque admiratione: [2] Gnaeum Seium quempiam scribam fuisse eumque habuisse equum natum Argis in terra Graecia, de quo fama constans esset, tamquam de genere equorum progenitus foret, qui Diomedis Thracis fuissent, quos Hercules Diomede occiso e Thracia Argos perduxisset |
Dicemmo di non volerlo, né si aspettava qualcosa di vantaggio da questa azione, e contemporaneamente sembrò giusto, renderti più consapevole, affinché se fosse accaduta qualcosa di tal genere i cittadini non pensassero fatta per nostra decisione, e perché non ci piace combattere con una ricompensa o un premio o gli inganni Tu, se non ti riguardi, morirai" [IX] Quale e di che genere sia stato quello che nel proverbio è detto cavallo seiano; e quale sia il colore dei cavalli che sono chiamati "spadici"; e sul motivo di tale termine [1] Gavio Basso nei suoi commentari, anche Giulio Modesto nel secondo libro delle questioni miscellanee tramandano sul cavallo seiano una storia degna di ricordo e ammirazione: [2] che c'era stato un certo scriba Gneo Seio e che aveva avuto un cavallo nato ad Argo nella terra della Grecia, sul quale perdurava la fama, come fosse generato dal tipo di cavalli, che erano stati del trace Diomede, che Ercole, ucciso Diomede, aveva portato dalla Tracia ad Argo |
Maybe you might be interested
| [3] Eum equum fuisse dicunt magnitudine invisitata, cervice ardua, colore poeniceo, flora et comanti iuba, omnibusque aliis equorum laudibus quoque longe praestitisse; sed eundem equum tali fuisse fato sive fortuna ferunt, ut, quisquis haberet eum possideretque, ut is cum omni domo familia fortunisque omnibus suis ad internecionem deperiret [4] Itaque primum illum Gnaeum Seium, dominum eius, a M Antonio, qui postea triumvirum reipublicae constituendae fuit, capitis damnatum miserando supplicio affectum esse; eodem tempore Cornelium Dolabellam consulem in Syriam proficiscentem fama istius equi adductum Argos devertisse cupidineque habendi eius exarsisse emisseque eum sestertiis centum milibus; sed ipsum quoque Dolabellam in Syria bello civili obsessum atque interfectum esse; mox eundem equum, qui Dolabellae fuerat, C Cassium, qui Dolabellam obsederat, abduxisse |
[3] Dicono che questo cavallo fosse di una grandezza indicibile, un'incollatura alta, un colore baio, una criniera folta e lucente, aver superato anche di molto tutti gli altri pregi dei cavalli; ma dicono che lo stesso cavallo per fatalità o caso fosse tale, che, chiunque lo tenesse e lo possedesse, così egli si rovinava fino alla morte con tutta la casa la famiglia e tutte le sue fortune [4] Pertanto (dicono) che il suo primo padrone quel Gneo Seio, essere stato sottoposto a un crudele supplizio condannato a morte da M Antonio, che poi fu triumviro della costituenda repubblica; che nello stesso tempo Cornelio Dolabella console in Siria attirato dalla fama di questo cavallo aver deviato dirigendosi verso Argo e aver smaniato per il desiderio di impossessarsi di questo e averlo pagato centomila sesterzi; ma che anche lo stesso Dolabella assediato nella guerra civile in Spagna ed essere stato ucciso; poi che lo stesso cavallo, che era stato di Dolabella, essere passato a C Cassio, che aveva assediato Dolabella |
| [5] Eum Cassium postea satis notum est victis partibus fusoque exercitu suo miseram mortem oppetisse; deinde post Antonium post interitum Cassii parta victoria equum illum nobilem Cassii requisisse et, cum eo potitus esset, ipsum quoque postea victum atque desertum detestabili exitio interisse [6] Hinc proverbium de hominibus calamitosis ortum dicique solitum: "ille homo habet equum Seianum" [7] Eadem sententia est illius quoque veteris proverbii, quod ita dictum accepimus: "aurum Tolosanum" Nam cum oppidum Tolosanum in terra Gallia Quintus Caepio consul diripuisset multumque auri in eius oppidi templis fuisset, quisquis ex ea direptione aurum attigit, misero cruciabilique exitu perit [8] Hunc equum Gavius Bassus vidisse Argis refert haut credibili pulcritudine vigoreque et colore exuberantissimo |
[5] E' abbastanza noto che questo Cassio poi sconfitti i partiti e distrutto il suo esercito incontrò una triste morte; che poi in seguito Antonio dopo la morte di Cassio riportata la vittoria aver preso quel famoso cavallo di Cassio e, essendosi impadronito di esso, anche lui stesso poi vinto ed abbandonato essere morto con una fine vergognosa [6] Da qui derivato il proverbio sugli uomini sfortunati ed esser detto di solito: "quell'uomo ha il cavallo seiano" [7] Uguale è anche il significato di quel vecchio proverbio, che abbiamo recepito detto così: "l'oro tolosano" Infatti il console Quinto Copione avendo distrutto le città di Tolosa nella nazione della Gallia ed essendoci molto oro nei templi di questa città, chiunque prese l'oro da questa distruzione, perì con una morte misera e crudele [8] Gavio Basso riferisce aver visto questo cavallo ad Argo certo d'incredibile bellezza e forza e di un colore molto vivace |
Maybe you might be interested
Gellio, Notti attiche: Liber 3, 1-3
Latino: dall'autore Gellio, opera Notti attiche parte Liber 3, 1-3
| [9] Quem colorem nos, sicuti dixi, "poeniceum" dicimus, Graeci partim phoinika, alii spadika appellant, quoniam palmae termes ex arbore cum fructu avulsus "spadix" dicitur [X] Quod est quaedam septenarii numeri vis et facultas in multis naturae rebus animadversa, de qua M Varro in hebdomadibus disserit copiose [1] M Varro in primo librorum, qui inscribuntur hebdomades vel de imaginibus, septenarii numeri, quem Graece hebdomada appellant, virtutes potestatesque multas variasque dicit [2] "Is namque numerus" inquit "septentriones maiores minoresque in caelo facit, item vergilias, quas pleiadas Graeci vocant, facit etiam stellas, quas alii "erraticas", P Nigidius "errones" appellat " [3] Circulos quoque ait in caelo circum longitudinem axis septem esse; ex quis duos minimos, qui axem extimum tangunt, polous appellari dicit; sed eos in sphaera, quae krikote vocatur, propter brevitatem non inesse |
[9] Colore che, come dissi, noi chiamiamo baio, i Greci chiamano rosso dattero, altri spadico, perché il ramo della palma staccato dall'albero col frutto è detto "spadice" [X] Cos'è una certa forza del numero sette e l'efficacia osservata in molti aspetti della natura, di cui ha parlato abbondantemente M Varrone negli hebdomadari [1] M Varrone nel primo dei libri, che sono intitolati hebdomades o sui ritratti, espone le virtù e le molte e varie proprietà del numero sette che in greco dicono hebdomas [2] "Infatti questo numero - dice- forma in cielo l'orsa maggiore e minore, anche le vergilie, che i Greci chiamano Pleiadi, forma anche le stelle, che altri chiamano "erratiche" P Nigidio "vaganti" [3] Dice anche che in cielo ci sono sette cerchi intorno alla lunghezza dell'asse; fra questi due minori, che toccano l'asse estremo, dice essere detti poli; ma che essi per la piccolezza non compaiono sulla sfera, che è detta armillare |
| [4] Ac neque ipse zodiacus septenario numero caret; nam in septimo signo fit solstitium a bruma, in septimo bruma a solstitio, in septimo aequinoctium ab aequinoctio [5] Dies deinde illos, quibus alcyones hieme anni in aqua nidulantur, eos quoque septem esse dicit [6] Praeterea scribit lunae curriculum confici integris quater septenis diebus; "nam die duodetricesimo luna", inquit "ex quo vestigio profecta est, eodem redit", auctoremque opinionis huius Aristidem esse Samium; in qua re non id solum animadverti debere dicit, quod quater septenis, id est octo et viginti, diebus conficeret luna iter suum, sed quod is numerus septenarius, si ab uno profectus, dum ad semetipsum progreditur, omnes, per quos progressus est, numeros comprehendat ipsumque se addat, facit numerum octo et viginti, quot dies sunt curriculi lunaris |
[4] E nemmeno lo stesso zodiaco è privo del numero sette; infatti nel settimo segno avviene il solstizio d'estate dopo l'inverno, nel settimo quello invernale dopo il solstizio estivo, nel settimo equinozio dopo equinozio [5] Inoltre dice che quei giorni, in cui nella stagione invernale dell'anno gli alcioni nidificano sull'acqua, anche questi sono sette [6] Inoltre scrive che il corso della luna si compie in quattro periodi in sette interi giorni, "infatti la luna nel ventottesimo giorno - dice- torna nello stesso punto da cui partì", e che fautore di quest'opinione era Aristide di Samo; al quale proposito dice che non si deve osservare questo solo, il fatto che in quattro periodi, cioè ventotto giorni, la luna compie il suo tragitto, ma il fatto che questo numero sette, se partito da uno, arriva fino al sette, racchiude tutti i numeri, attraverso cui passò e aggiunge se stesso, forma il numero ventotto, quanti sono i giorni del corso lunare |
Maybe you might be interested
Gellio, Notti attiche: Liber 13, 7-12
Latino: dall'autore Gellio, opera Notti attiche parte Liber 13, 7-12
| [7] Ad homines quoque nascendos vim numeri istius porrigi pertinereque ait: "Nam cum in uterum" inquit "mulieris genitale semen datum est, primis septem diebus conglobatur coagulaturque fitque ad capiendam figuram idoneum Post deinde quarta hebdomade, quod eius virile secus futurum est, caput et spina, quae est in dorso, informatur Septima autem fere hebdomade, id est nono et quadragesimo die, totus" inquit "homo in utero absolvitur " [8] Illam quoque vim numeri huius observatam refert, quod ante mensem septimum neque mas neque femina salubriter ac secundum naturam nasci potest et quod hi, qui iustissime in utero sunt, post ducentos septuaginta tres dies, postquam sunt concepti, quadragesima denique hebdomade inita nascuntur |
[7] Dice che l'influenza di tale numero viene estesa e riguarda anche gli uomini che devono nascere: "Infatti quando è stato immesso il seme genitale nell'utero della donna, nei primi sette giorni s'addensa e si coagula e diventa adatto ad assumere una forma Poi dopo la quarta settimana, ciò che di questo sarà il sesso maschile, si forma il capo e la spina, che è sul dorso Invece circa nella settima settimana, cioè nel quarantanovesimo giorno, tutto l'essere- dice- è completato nell'utero" [8] Riferisce essere anche stata notata quell'influenza di questo numero, il fatto che prima del settimo mese né un maschio né una femmina può nascere in modo sano e secondo natura e il fatto che quelli, che restano molto regolarmente nell'utero, nascono dopo duecentosettantatre giorni, dopo che sono concepiti, dunque nella quarantesima settimana iniziata |
| [9] Pericula quoque vitae fortunarumque hominum, quae "climacteras" Chaldaei appellant, gravissimos quosque fieri affirmat septenarios [10] Praeter hoc modum esse dicit summum adolescendi humani corporis septem pedes [11] Quod esse magis verum arbitramur, quam quod Herodotus, homo fabulator, in primo historiarum inventum esse sub terra scripsit Oresti corpus cubita longitudinis habens septem, quae faciunt pedes duodecim et quadrantem, nisi si, ut Homerus opinatus est, vastiora prolixioraque fuerunt corpora hominum antiquiorum et nunc quasi iam mundo senescente rerum atque hominum decrementa sunt [12] Dentes quoque et in septem mensibus primis et septenos ex utraque parte gigni ait et cadere annis septimis et genuinos adnasci annis fere bis septenis |
[9] Anche quelli rischiosi della vita e dei beni degli uomini, che i Caldei chiamano climaterici", afferma che i più dannosi sono quelli formati dal sette [10] Inoltre dice che questa misura la massima di crescita del corpo umano è di sette piedi [11] Pensiamo essere ciò più vero, di quello che Erodoto, un narratore, scrisse nel primo libro delle storie essere stato trovato sotto terra il corpo di Oreste che aveva sette cubiti di lunghezza, che fanno dodici piedi e un quarto, a meno che, come pensò Omero, i corpi degli antichi uomini furono più grandi e più alti ed ora quasi divenendo ormai vecchio il mondo ci sono riduzioni di cose e uomini [12] Dice che anche i denti spuntano nei primi sette mesi e sette da entrambi i lati e cadono a sette anni e che i molari crescono generalmente a quattordici anni |
| [13] Venas etiam in hominibus vel potius arterias medicos musicos dicere ait numero moveri septenario, quod ipsi appellant ten dia tessaron symphonian, quae fit in collatione quaternarii numeri [14] Discrimina etiam periculorum in morbis maiore vi fieri putat in diebus, qui conficiuntur ex numero septenario, eosque dies omnium maxime, ita ut medici appellant, krisimous videri: primam hebdomadam et secundam et tertiam [15] Neque non id etiam sumit ad vim facultatesque eius numeri augendas, quod, quibus inedia mori consilium est, septimo demum die mortem oppetunt [16] Haec Varro de numero septenario scripsit admodum conquisite |
[13] Dice che i medici che curano con la musica affermano che anche le vene negli uomini e piuttosto le arterie sono mosse con ritmo settenario, cosa che essi stessi definiscono accordo di quarta, che risulta nella sintonia del ritmo quaternario [14] Anche i rischi dei pericoli nelle malattie ritiene verificarsi con maggiore violenza nei giorni, che sono ricavati da un numero multiplo di sette, e di tutti sembrarlo soprattutto quei giorni, cosicché i medici definiscono critici: la primasettimana e la seconda e la terza [15] Ed ammette anche ciò riguardo alla potenza e alle influenze da aggiungere di questo numero, il fatto che, per quelli per i quali c'è la scelta di morire di fame, raggiungono infine la morte al settimo giorno [16] Varrone scrisse alquanto diligentemente queste cose sul numero sette |