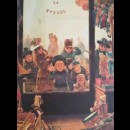| [XXV] Quaesitum tractatumque, quid sint "manubiae"; atque inibi dicta quaedam de ratione utendi verbis pluribus idem significantibus [I] In fastigiis fori Traiani simulacra sunt sita circum undique inaurata equorum atque signorum militarium, subscriptumque est: "ex manubiis" [II] Quaerebat Favorinus, cum in area fori ambularet et amicum suum consulem opperiretur causas pro tribunali cognoscentem nosque tunc eum sectaremur, quaerebat, inquam, quid nobis videretur significare proprie "manubiarum" illa inscriptio [III] Tum quispiam, qui cum eo erat, homo in studiis doctrinae multi atque celebrati nominis: ""ex manubiis"" inquit "significat "ex praeda"; manubiae enim dicuntur praeda, quae manu capta est" |
[XXV] Chiesto e discusso, cosa siano le "manubiae"; e inoltre alcune cose dette sul motivo di usare più parole che significano una stessa cosa [I] Sui fastigi del foro di Traiano sono collocate intorno statue dorate di cavalli da ogni parte e di stendardi militari, e vi fu sottoscritto: "ex manubiis" [II] Favorino chiedeva, passeggiando nella zona del foro e aspettando un suo amico console che giudicava le cause per conto del tribunale ed allora mentre noi lo seguivamo, chiedeva, dico, cosa ci sembrava voler dire propriamente quell'iscrizione "delle manubie" [III] Allora un tale, che era con lui, uomo di grande e rinomata fama negli studi di cultura disse: "Ex manubiis significa "dalla preda"; infatti sono dette manubie la preda, che è stata presa con la mano" |
| [IV] "Etiamsi" inquit Favorinus "opera mihi princeps et prope omnis in litteris disciplinisque Graecis sumpta est, non usque eo tamen infrequens sum vocum Latinarum, quas subsicivo aut tumultuario studio colo, ut hanc ignorem manubiarum interpretationem vulgariam, quod esse dicantur manubiae praeda Sed quaero, an M Tullius, verborum homo diligentissimus, in oratione, quam dixit de lege agraria Kalendis Ianuariis contra Rullum, inani et inlepida geminatione iunxerit "manubias" et "praedam", si duo haec verba idem significant neque ulla re aliqua dissident " [V] Atque, ut erat Favorinus egregia vel divina quadam memoria, verba ipsa M Tulli statim dixit [VI] Ea nos hic adscripsimus: "Praedam, manubias, sectionem, castra denique Cn |
[IV] Favorino disse: "Sebbene per me l'attività principale e quasi completa fu impegnata nelle letterature e nelle conoscenze greche, tuttavia non sono così inesperto di termini latini, che coltivo con lo studio rimanente e irregolare, che io ignori questa comune spiegazione delle manubie, che le manubie sono dette essere la preda Ma chiedo, forse M Tullio, uomo molto esperto delle parole, nell'orazione, che pronunciò sulla legge agraria contro Rullo nelle calende di Gennaio, ha unito con inutile e inelegante ripetizione "manubias" e "praedam", se queste due parole significano la stessa cosa e non differiscono in nessun'altra cosa " [V] E, poiché Favorino era di una notevole e quasi divina memoria, disse subito le stesse parole di M Tullio [VI] Qui le abbiamo riportate: "I decemviri vendono il bottino, le spoglie, la confisca, infine gli accampamenti di Cn |
| Pompei sedente imperatore decemviri vendent"; et infra itidem duo haec simul iunctim posita dixit: "Ex praeda, ex manubiis, ex auro coronario" [VII] Ac deinde ad eum convertit, qui manubias esse praedam dixerat, et: "videturne tibi" inquit "utroque in loco M Cicero duobus verbis idem, sicuti tu putas, significantibus inepte et frigide esse usus ac tali ioco dignus, quali apud Aristophanen, facetissimum comicorum, Euripides Aeschylum insectatus est, cum ait: dis tauton hemin eipen ho sophos Aischylos heko gar eis gen, phesi, kai katerchomai; heko de tauton esti toi katerchomai Ne ton Di', hosper g'ei tis eipoi geinotoi; chreson sy maktran, ei de boulei, karpodon " [VIII] "Nequaquam vero" inquit ille "talia videntur, quale est maktra et karpodos, quae vel a poetis vel oratoribus Graecis nostrisque celebrandae et ornandae rei gratia duobus eadem pluribusve nominibus frequentantur |
Pompeo mentre il generale assiste"; e ancora sotto disse questi due termini congiuntamente insieme: "dal bottino, dalle spoglie, dall'oro coronario" [VII] E poi si volse verso quello, che aveva detto che le manubie erano la preda, e disse: "M Cicerone in entrambi i passi ti sembra, come credi, aver usato superficialmente e inadeguatamente, due termini che indicano, la stessa cosa e degno di uno scherno tale, quale presso Aristofane, il più scherzoso dei comici, Euripide schernì Eschilo, quando dice: il saggio Eschilo dice due volte la stessa cosa; a questa terra ecco torno, dice, e faccio ritorno; ebbene torno è lo stesso di faccio ritorno Già per Dio, come se uno dicesse al vicino; prestami la mastra, o se preferisci la madia " [VIII] Quello rispose: "Certo non sembrano affatto cose uguali, cosa è la mastra e la madia, che sia dai poeti sia dagli oratori greci e dai nostri sono usate per esaltare e ornare le stesse cose con due o più termini" |
Maybe you might be interested
Gellio, Notti attiche: Liber 11, 17-18
Latino: dall'autore Gellio, opera Notti attiche parte Liber 11, 17-18
| " [IX] "Quid igitur" inquit Favorinus "valet haec repetitio instauratioque eiusdem rei sub alio nomine in "manubiis" et in "praeda" num ornat, ut alioqui solet, orationem num eam modulatiorem aptioremque reddit num onerandi vel exprobrandi criminis causa exaggerationem aliquam speciosam facit sicut in libro eiusdem M Tulli, qui de constituendo accusatore est, una eademque res pluribus verbis vehementer atque atrociter dicitur: "Sicilia tota, si una voce loqueretur, hoc diceret: "quod auri, quod argenti, quod ornamentorum in meis urbibus, sedibus, delubris fuit"" Nam cum urbes semel totas dixisset, sedes delubraque addidit, quae sunt ipsa quoque in urbibus [X] Item in eodem libro simili modo: "Siciliam" inquit "provinciam C Verres per triennium depopulatus esse, Siculorum civitates vastasse, domos exinanisse, fana spoliasse dicitur" |
[IX] "Cosa serve dunque -dice Favorino- questa ripetizione e la replica di questo concetto sotto altro nome in "manubiis" e in "preda" Forse orna l'orazione, come suole altrove Forse tende più modulata e più idonea questa modulazione Forse allo scopo di un crimine da aggravare o biasimare effettua una qualche particolare aggravio Come nel libro dello stesso M Tullio, che si basa sulla scelta di un accusatore, una stessa cosa viene detta vigorosamente e aspramente con più termini: "La Sicilia intera, se parlasse con una sola voce, direbbe questo: "Ciò che di oro, ciò che d'argento, ciò che d'ornamenti ci fu nelle mie città, edifici, templi" Infatti avendo detto dapprima le città intere, aggiunge edifici e templi, le stesse cose che sono anche nelle città [X] Anche nello stesso libro in ugual modo: "C Verre - dice- devastò per tre anni la provincia della Sicilia, si dice aver distrutto le città dei Siciliani, aver svuotato le case, aver spogliato i templi |
| [XI] Ecquid videtur, cum Siciliam provinciam dixerit atque insuper etiam civitates addiderit, domos etiam et fana, quae infra posuit, conprehendisse Verba haec item multa atque varia: "depopulatus esse, vastasse, exinanisse, spoliasse", nonne unam et eandem vim in sese habent Sane Sed quia cum dignitate orationis et cum gravi verborum copia dicuntur, quamquam eadem fere sint et ex una sententia cooriantur, plura tamen esse existimantur, quoniam et aures et animum saepius feriunt [XII] "Hoc ornatus genus in crimine uno vocibus multis atque saevis exstruendo ille iam tunc M |
" [XI] Cosa significa, avendo nominato la provincia della Sicilia e avendo aggiunto sopra anche le città, aver compreso anche le case e i templi, che inserì più sotto Queste parole anche numerose e varie: "Aver devastato, aver distrutto, aver svuotato, aver spogliato", non hanno una sola e identica forza in sé Certo Ma poiché sono dette con lo stile di un'orazione e con forte abbondanza di termini, sebbene siano generalmente le stesse cose e sono originate da una sola nozione, tuttavia sono considerate essere diverse, perché colpiscono più frequentemente sia le orecchie sia l'animo [XII] "Già allora M |
Maybe you might be interested
Gellio, Notti attiche: Liber 1, 14-15
Latino: dall'autore Gellio, opera Notti attiche parte Liber 1, 14-15
| Cato antiquissimus in orationibus suis celebravit, sicut in illa, quae inscripta est de decem hominibus, cum Thermum accusavit, quod decem liberos homines eodem tempore interfecisset, hisce verbis eandem omnibus rem significantibus usus est, quae quoniam sunt eloquentiae Latinae tunc primum exorientis lumina quaedam sublustria, libitum est ea mihi apomnemonevein: "Tuum nefarium facinus peiore facinore operire postulas, succidias humanas facis, tantam trucidationem facis, decem funera facis, decem capita libera interficis, decem hominibus vitam eripis indicta causa, iniudicatis, indemnatis" [XIII] Item M Cato in orationis principio, quam dixit in senatu Pro Rhodiensibus, cum vellet res nimis prosperas dicere, tribus vocabulis idem sentientibus dixit |
Catone il più antico esaltò nelle sue orazioni questo metodo ornato nel distruggere con molte e severe parole un solo crimine, come in quella, che fu intitolata sui dieci uomini, quando accusò Termo, perché aveva ucciso dieci uomini liberi nello stesso tempo, usò queste parole che significavano tutte la stessa cosa, le quali poiché sono taluni bagliori lucenti dell'allora nascente eloquenza latina, mi è gradito ricordarle: "Tu chiedi di coprire un tuo atto criminale con un atto peggiore, fai stragi umane, provochi tanto eccidio, causi dieci morti, uccidi dieci persone libere, togli la vita a dieci uomini senza ascoltare la difesa, non giudicati, non condannati" [XIII] Anche M Catone all'inizio dell'orazione, che pronunciò nel senato A favore dei Rodesi, volendo presentare situazioni molto prospere, s'espressse con tre parole che significavano la stessa cosa |
| [XIV] Verba eius haec sunt: "Scio solere plerisque hominibus in rebus secundis atque prolixis atque prosperis animum excellere atque superbiam atque ferociam augescere" [XV] Itidem Cato ex originum VII in oratione, quam contra Servium Galbam dixit, conpluribus vocabulis super eadem re usus est: "Multa me dehortata sunt huc prodire, anni, aetas, vox, vires, senectus; verum enimvero cum tantam rem peragier arbitrarer," [XVI] "Sed ante omnis apud Homerum eiusdem rei atque sententiae luculenta exaggeratio est: Hektora d'ek beleon hypage Zeus ek te konies ek t'androktasies ek th'haimatos ek te kydoimou Item in alio versu: hysminai te machai te phonoi t'androktasiai te [XVII] Nam cum omnia ista utrobique multa et cognominata nihil plus demonstrent quam proelium, huius tamen rei varia facies delectabiliter ac decore multis variisque verbis depicta est |
[XIV] Queste sono le sue parole: "So che a molti uomini nelle situazioni favorevoli e fortunate e prospere l'animo suole inorgoglirsi e la superbia e la crudeltà aumentare" [XV] Ugualmente Catone nella 7° orazione delle origini, che disse contro Servio Galba, usò diversi vocaboli sullo stesso concetto: "Molte cose mi sconsigliarono di venire qui, gli anni, l'età, la voce, le forze, la vecchiaia; ma pensando dunque che tale argomento era trattato," [XVI] "Ma prima di tutto in Omero c'è una ripetizione brillante di uno stesso argomento e significato: Zeus salvò Ettore dai dardi e dalla polvere dalla strage dal tumulto e dal sangue Anche in un altro verso: mischie e battaglie e massacri d'eroi [XVII] Infatti poiché in entrambe le parti tutte queste molte cose e definizioni non significhino niente più, che battaglia, tuttavia il vario aspetto di quest'argomento fu descritto gradevolmente ed elegantemente con molte e varie parole |
| [XVIII] Neque non illa quoque aput eundem poetam una in duobus verbis sententia cum egregia ratione repetita est: Idaeus enim, cum inter Aiacem et Hectorem decertantes armis intercederet, bis ad eos verbis usus est: meketi, paide philo, polemizete mede machesthe, [XIX] in quo versu non oportet videri alterum verbum idem, quod superius, significans supplendi numeri causa extrinsecus additum et consarcinatum Est enim hoc inane admodum et futtile Sed cum in iuvenibus gloriae studio flagrantibus pervicaciam ferociamque et cupidinem pugnae leniter tamen ac placide obiurgaret, atrocitatem rei et culpam perseverandi bis idem dicendo alio atque alio verbo auxit inculcavitque, duplexque eadem conpellatio admonitionem facit instantiorem |
[XVIII] Eppure quello stesso pensiero fu ripetuto anche presso lo stesso poeta in due parole con notevole effetto: Infatti Ideo, mettendo fine al duello tra Aiace ed Ettore che combattevano, usò verso di loro due volte le parole: non lottate, cari figli, non combattete ancora, [XIX] nel quale verso non si deve supporre che l'altra parola, che significa quella precedente, fu aggiunta e cucita senza motivo per un verso da completare Infatti ciò è completamete falso e inutile Ma rimproverando tuttavia tranquillamente e pacatamente l'ostinata fierezza e l'ardore della lotta nei giovani che combattevano per il desiderio di gloria, aumentò ed inculcò l'atrocità della situazione e la colpa di continuare col dire due volte la stessa ora con una ora con un'altra parola, e la stessa duplice forza rende l'ammonimento più incalzante |
| [XX] Ne illa quidem significationis eiusdem repetitio ignava et frigida videri debet: mnesteres d'ara Telemachoi thanaton te moron te ertyon, quod bis idem: thanaton et moron dixerit; indignitas enim moliendae tam acerbae tamque iniustae necis miranda mortis iteratione defleta est [XXI] Ceterum quis tam obtunso ingeniost, quin intellegat: bask'ithi, oule Oneire, et bask'ithi, Iri tacheia, verba idem duo significantia non frustra posita esse ek parallelon, ut quidam putant, sed hortamentum esse acre imperatae celeritatis [XXII] "Verba quoque illa M Ciceronis in L |
[XX] Né certo quella ripetizione di uno stesso significato deve sembrare fiacca e fredda: ma contro Telemaco i pretendenti tramano morte e rovina, questa stessa cosa due volte: ha detto morte e rovina; infatti l'indignazione della ricerca di una tanto crudele e ingiusta uccisione fu deplorata con una mirabile ripetizione della morte [XXI] Del resto chi è d'intelligenza tanto ottusa, che non capisca che in: va', Sogno cattivo, e muoviti, Iri veloce, non inutilmente sono state inserite due parole che indicano la stessa cosa e in parallelo, come alcuni pensano, ma essere fortemente un'esortazione di imposta velocità [XXII] "Anche quelle triplici parole di M Cicerone verso L |
| Pisonem trigemina, etiamsi durae auris hominibus non placent, non venustatem modo numeris quaesiverunt, sed figuram simulationemque oris pluribus simul vocibus verberaverunt: [XXIII] "Vultus denique" inquit "totus, qui sermo quidam tacitus mentis est, hic in fraudem homines impulit, hic eos, quibus erat ignotus, decepit, fefellit, induxit" [XXIV] Quid igitur simile est" inquit "apud eundem in "praeda" et "manubiis" Nihil profecto istiusmodi [XXV] Nam neque ornatius fit additis manubiis neque exaggeratius modulatiusve; sed aliud omnino "praeda" est, ut in libris rerum verborumque veterum scriptum est, aliud "manubiae" [XXVI] Nam praeda dicitur corpora ipsa rerum, quae capta sunt, manubiae vero appellatae sunt pecunia a quaestore ex venditione praedae redacta [XXVII] Vtrumque ergo dixit M |
Pisone, sebbene non piacciano agli uomini d'orecchio insensibile, non richiesero solo l'eleganza del ritmo, ma ribatterono l'aspetto e la finzione del viso contemporaneamente con più parole [XXIII] "Infine tutto il volto - dice-, che è un certo muto linguaggio della mente, questo trasse in inganno gli uomini, questo sviò, frodò, imbrogliò coloro a cui era ignoto" [XXIV] Che dunque - dice- è uguale come la stessa cosa in "preda" e "manubiis" Certo nulla di tal genere [XXV] Infatti né diventa più adorno con i manubri aggiunti né più ampio o più armonioso; ma certo significa una cosa "preda", come fu scritto nei libri delle gesta e delle parole antiche, un'altra "manubiae" [XXVI] Infatti si chiama bottino gli oggetti stessi delle cose, che furono prese, invece furono dette manubiae i denari ricavati dal questore dalla vendita del bottino [XXVII] Perciò M |